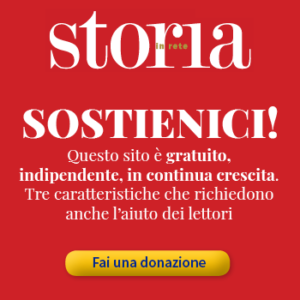Chi l’avrebbe mai detto? Caterina de’ Medici, la machiavellica regina di Francia, era un’ingenua che si fece menare per il naso dalla sua damigella di corte per decenni, senza avere il minimo sospetto! Che scoperta sensazionale! Ma è davvero una scoperta, o una bufala?
Facciamo un passo indietro. Nel 2018 è uscito il mio Caterina de’ Medici. Storia segreta di una faida famigliare (tradotto in varie lingue incluso il francese) in cui racconto la lotta fra i Medici e gli Strozzi, la dinastia di banchieri che a fasi alterne avevano sostenuto o avversato il regime mediceo. Caterina, ultima discendente del ramo principale dei Medici di Cafaggiuolo, è il fulcro di questa lotta.
Nel 1547, suo cugino Cosimo I, duca di Firenze (1519 – 1574), che dal punto di vista di Caterina è un parvenu, un indegno rappresentante della propria famiglia, libera tale Antonio Gazzetti, il fratello della dama di compagnia della regina che guarda caso si chiama come lei, Caterina Gazzetti (d’ora in poi la chiameremo Gazzetta, come del resto facevano i suoi contemporanei). Antonio in cambio deve fare la talpa a casa degli Strozzi, i cugini cattivi della regina, che il duca detesta. Per qualche mese, sembra che Antonio sia disposto a collaborare, e passa qualche briciolo d’informazione. Poi viene scoperto, e incarcerato, con vergogna dell’ambasciatore fiorentino che riparte con la coda fra le gambe.
Uno studioso francese alle prime armi, Pierre Nevejans, ha scritto un libretto intitolato La cour, nid d’espions.Caterina Gazzetti, Une espionne à la cour de Catherine de Médicis (hobg 2024). Mi sono disposto alla lettura con curiosità, anche perché egli ha preso parte al Medici Archive Project, una comunità di studiosi alla quale appartengo da anni. Ma Nevejans ha agito in solitaria, senza consultarsi con storici più esperti, forse per preservare gelosamente il suo presunto “scoop”.
L’autore ha preso un brano del mio libro su Caterina e lo ha trasformato in un mini-thriller, et voilà! Il libro si apre con la citazione di una minuta cifrata di Cosimo de’ Medici al suo ambasciatore in Francia, Giovan Battista Ricasoli. Nevejans avverte subito che fornirà “traduzioni personali” dei documenti originali per renderli comprensibili “al lettore del ventunesimo secolo”, ma chiaramente ha serie difficoltà a leggere la prosa del sedicesimo secolo. Andando a verificare l’italiano, scopriamo che la sistematica manipolazione delle fonti porta a gravi malintesi. Antonio Gazzetti non faceva quello che avrebbe dovuto fare (accettare di informare il duca) e bisognava rimetterlo in carreggiata, offrendogli una lauta ricompensa in denaro. Cosimo scrive che Gazzetti si mostra “sconoscente”, ma nella versione francese diventa “reconnaissant” (“riconoscente”); le sue “parole affettate” (cioè ipocrite) diventano “affectueuses” (“affettuose”), e così via. Insomma, si fraintende il tono negativo volgendolo in positivo e si trasforma l’irritazione in approvazione ducale.
L’inizio è già poco promettente, ma c’è di peggio. Nel ricostruire le vicende giudiziarie di Antonio l’autore aggiunge qualche dettaglio sulle modalità della sua scarcerazione (pur senza dire niente sulle sue attività per conto degli Strozzi), ma l’ossessione di dimostrare la propria tesi lo porta fuori strada. Senza ricordare tutti i passaggi, il punto cruciale è che cita (in francese) la seguente lettera di Ricasoli al segretario cosimiano Cristiano Pagni, scritta da Firenze il 29 marzo 1549 (non 1550, e fa una grande differenza perché Antonio è ancora incarcerato!):
Questa donna de’ Gazzetti [Caterina? NO! è la madre!] la quale per l’ordinario ogni dui giorni mi viene a trovare, il che non mi pare per molti respetti convenga et però vi piacerà parlarne con S. Ex. et far ogni opera in quel modo gli piacerà risolverla, per quanto da lei posso ritrarre ancor che con lachrime domandi 500 ducati, il bisogno suo presente sarebbe di 260.
Nevejans non capisce e scrive che «elle lui enverrait une lettre tous les deux jours» ! Su questo assurdo malinteso (la donna che batte cassa è a Firenze, non in Francia!) costruisce una teoria secondo la quale l’ingenua regina si sarebbe tenuta in casa fino al 1576 una spiona di Cosimo, a cui avrebbe mandato rapporti spionistici ogni due giorni! Non si pone neanche il problema di come una simile corrispondenza compromettente potesse viaggiare indisturbata per tanti chilometri e tanti anni, anche se non può ovviamente fornire nessuna prova di tale teoria (perché è del tutto falsa).
Per rendere le cose più divertenti, invece di tradurre correttamente “per l’ordinario” con l’espressione “comme d’habitude”, si lancia in una disquisizione sulla posta ordinaria. Lo sforzo in questo caso è straordinario! L’autore mostra un’acrobatica capacità di arrampicarsi sugli specchi, degna di miglior causa. Se ci fosse qualche dubbio sull’identificazione della “donna de’ Gazzetti”, lo elimina una volta per tutte un dispaccio decifrato di Ricasoli a Cosimo del 23 febbraio 1548:
Gazetto mi ha mostro per un suo bilancio aver nel dominio di Vostra Eccellenza beni per 2mila e cinquecento scudi, […] perché la madre ha debito cinquecento scudi”.
Les jeux sont faits!
Si potrebbero elencare i numerosi altri errori e omissioni (e lo faremo in separata sede), ma il punto di questo blog è mostrare che non si possono scrivere libri di storia se non si capiscono le semplici nuances della lingua in cui sono scritte le fonti.
Tuttavia, l’autore è insistente: come giustificare la totale assenza di rapporti della Gazzetta? Pas de souci, sono tutti perduti! In altre parole, l’unica prova per la tesi centrale del libro è un grossolano malinteso tirato per i capelli per decine di pagine.
Verso la fine, Nevejans sembra sfiorato da un’esitazione: e se i Gazzetti non fossero serviti a nulla? Forse no, ma non importa. È una bella storia! La regina gabbata dalla serva diventerà una sceneggiatura, come suggeriscono i ripetuti riferimenti a serie televisive come Homeland o a Netflix, che invece di dare un tono leggero aumentano il senso di compiaciuta superficialità. Non meno fastidiose sono le saccenti allusioni alle lettere della regina di Francia che non vengono quasi mai citate (anche perché indebolirebbero ulteriormente la tesi del libro). In conclusione, questo atto di esibizionismo archivistico denuda l’evidente incompetenza dell’autore in paleografia e in crittografia (su cui si vedano i miei altri recenti blog).
È un peccato perché è un’occasione perduta: si potrebbero affrontare veri casi di spionaggio e controspionaggio, esempi su cui sto scrivendo ora in un libro su Aretino e la Corte, che era un “nido di spie” e “la scena della menzogna”, come ci ricordava il grande studioso Amedeo Quondam. I libri, anche se divulgativi, non devono essere dei nidi di errori e di fake news.