Jean Giono in “Il disastro di Pavia” racconta un’epoca feroce ma vibrante di emozioni
di Matteo Sacchi da Il Giornale del 29 Luglio 2023
Finì come doveva finire. Con tanti, che si sognavano Lancillotto, impallinati senza speranza dagli archibugi a forcella. A Pavia, il 24 febbraio 1525, i più bei nomi della nobiltà di Francia, personaggi di un coraggio squisito e raro, adusi a uccidere da signori, finirono per diventare concime. Ecco, elenchiamone alcuni, perché non si entra a una grande festa, quale per loro era la battaglia, senza essere annunciati, men che meno se ne esce (da eroi morti): Francesco di Lorena, Jacques de La Palice, Louis de la Trémoille, Guillaume Gouffier de Bonnivet, Renato di Savoia-Villars, Pietro II di Rohan Gié, Thomas de Foix-Lescun morto qualche giorno dopo per le ferite… E potremmo andare avanti a lungo nell’elencare tutti quelli che è stato necessario ammazzare per consentire a Carlo V, imperatore borghese che andava per campi di battaglia in portantina, di farsi consegnare un Francesco I, pestato a dovere e salvo a stento dal campo di battaglia. Un re galante e frivolo, cavalleresco sino alle midolla, prigioniero di un imperatore aduso a fare bene i conti quasi come un mercante. Ma se ci sono un vincitore e un vinto, tra i grandi impresari dello spettacolo cruento di Pavia, va detto che entrambe le compagnie di giro, quella francese e quella spagnola, sono state organizzate allo stesso modo. Raccattando la più bizzarra mescolanza di nobili e di mercenari, di cavalieri in armatura e di straccioni con le picche, di fanti svizzeri e di colorati lanzichenecchi. Alla fine Francesco I ha scelto solo la prima donna sbagliata, quel Guillame Gouffier de Bonnivet a cui non si potrà rimproverare niente. Pessimo comandante, bravissimo a morire sul campo con stile.
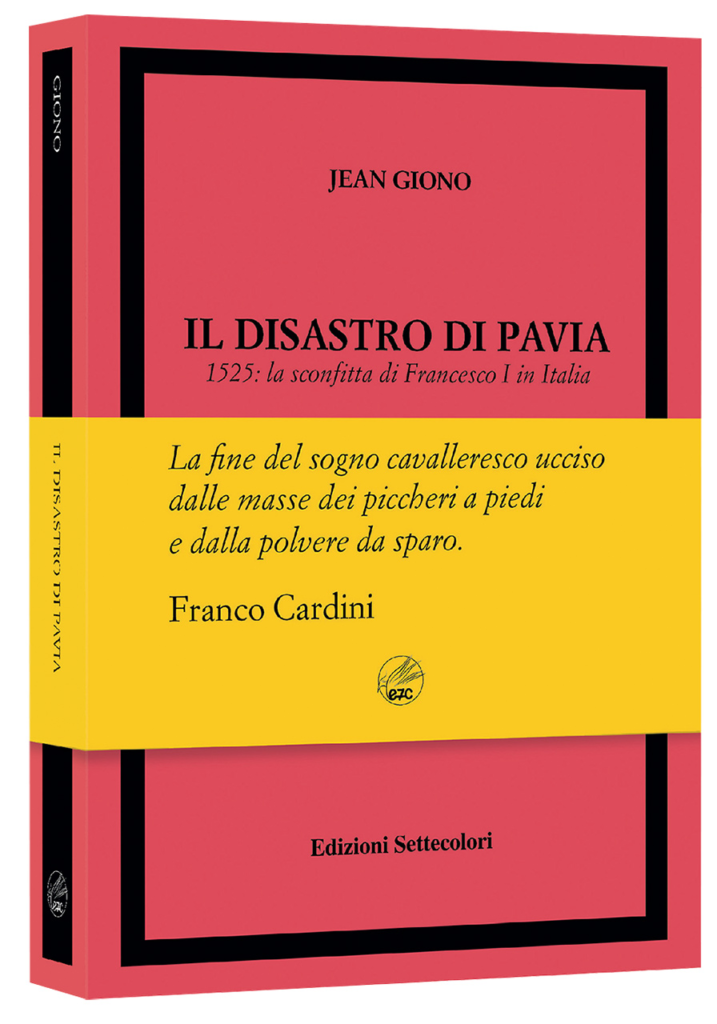
Sin qui la Storia, quella arrivata a posteriori, a mettere ordine nella grande gazzarra nota come guerre d’Italia, al cui centro campeggia, per enormità di risultati e di strage, la Battaglia di Pavia. Poi c’è Jean Giono, che nel 1963 pubblica per l’editore Gallimard Il disastro di Pavia ora nelle librerie italiane per i tipi di Edizioni Settecolori (pagg. 382, euro 25, con una prefazione di Giuseppe Scaraffia e una postfazione di Franco Cardini). Giono (1895 – 1970) riesce in questo saggio, letterario come un romanzo e enciclopedicamente colto, a guardare il caos della battaglia per catturare qualcosa che, raramente, si fa incatenare sulla carta: lo spirito dei tempi e i desideri degli uomini. Lo fa inseguendo fili sottili, microstorie, che gli storici professionisti hanno iniziato a guardare in questo modo molto dopo, e non sempre con la genialità del grande letterato.
Giono, che era così pacifista da essere stato scambiato per filotedesco, prima e dopo la Seconda guerra mondiale, che aveva provato tutto l’orrore delle tempeste d’acciaio della Grande guerra, riesce a fare, e a far fare al lettore, un salto nella mente dei convenuti, volontari, alla grande strage attorno a Pavia. Coglie il lato folle, spontaneo e ludico di molti dei nobili e dei mercenari che decisero di giocarsi la vita con la stessa tranquillità con cui, oggi, si decide di guidare un’automobile. C’è calcolo in Carlo V? Sì, ma con senso di colpa. C’è calcolo in Francesco I, sì ma rallentato dal desiderio di essere sempre e comunque «il più bello». Nel XVI secolo la patria non esiste, ma di sicuro esiste l’onore ed esiste lo sport: «È qualcosa di romanzesco: è la caccia, il torneo, la guerra; l’Orlando furioso è un manuale di sport». Così arriva sul campo la nobiltà francese. Così ci arriva la nobiltà spagnola, del resto tra i comandanti di Carlo V c’è anche un potente feudatario francese, Carlo di Borbone-Montpensier. Vincerà a Pavia non sentendosi affatto francese ma soltanto un uomo che è stato trattato male da Francesco I e, quindi, in pieno diritto di dare una sistemata alle cose. Morirà all’assedio di Roma, dove poi i lanzichenecchi metteranno al sacco la città, nel 1527. Ma questo è solo uno delle decine di esempi di come nobili e villani si gettino nel crogiolo della guerra come una questione privata. Spiega Giono: «E se tutti vanno a battersi in Italia… noi non possiamo immaginare che tutti siano dei frivoli o degli stupidi, soprattutto stupidi fino a questo punto. Il fatto è che nel momento in cui fanno quello che fanno è più importante per loro di quello che a noi sembra importante per i quattrocento anni a seguire». Lo Stato non esiste ancora: esistono, ma spariranno presto, gli uomini. Magari con un senso dell’esistere completamente belluino ma per certi versi ancora profondamente umano: «Non sacrificano mai la vita per delle idee; per loro non è difficile morire perché muoiono per dei motivi che non riguardano che loro stessi».
Vale anche per i piani bassi della strage, per il lanzichenecco vestito a vivaci colori che ha sostituito la fame con la guerra? Questa ideologia del coraggio, alla fine, contagia tutti. I mercenari cambiano continuamente campo, mugugnano, chiedono più soldi, mercanteggiano. Dicono che se non succede questo o quello non combatteranno un giorno di più. Ma è un modo di contare, di essere sé stessi, fossero rimasti nei campi non se lo sarebbero potuti permettere. «Non hanno problemi di coscienza: già da tempo la miseria gli ha trasmesso la certezza della loro esistenza». E per ribadirla, questa esistenza, vanno dritti verso la fucileria nemica e muoiono. Ma vivi e spacconi. Si può essere spacconi alla borgognona, alla spagnola, alla tedesca, ma poco cambia. «Tutti sembrano far parte di un club più che di un esercito». E infatti questi eserciti si comandavano molto poco. Passando attraverso la galleria di ritratti del libro, dal nobile al mercenario straccione – i nobili son di più ma solo per questione di fonti – si ha l’impressione di passare davanti ad una galleria di mostri. Mostri per cui il pacifista Giono non ha alcuna fascinazione malata, sia chiaro, e di cui non nasconde alcuna bassezza gratuita o fragilità.
E però Giono usa i fantasmi di questi uomini, per costruire uno specchio. In cui guardare la follia delle nostre distrazioni, non necessariamente più innocenti delle loro.
«Il cinema (e intendo come cinema ogni fabbrica di illusioni) ci consente di compiere i nostri crimini senza fatica, senza pericolo, in poltrona. Il grande affare dei tempi moderni finisce per essere la poltrona nella quale si può fare di tutto: arrivare in una poltrona, essere un cowboy in una poltrona, essere il più forte in una poltrona… Ne consegue un incremento di divertimento immobile e una paura che diventa man mano panico».
La gente di Pavia avrebbe detestato la poltrona, financo quella mobile di un treno di prima classe. «Preferivano essere di persona sulla scena, sullo schermo. Questa voglia di morte era un’arte di vivere: prendevano la vita nera e senza zucchero, come il caffè quando se ne ama molto il sapore».
Giono, il pacifista, guardando attraverso il fumo della battaglia ci regala degli esseri umani che pian piano smettono di sembrare folli. I principi e i lanzichenecchi, pur nella grande distanza tra di loro, ci appaiono fratelli nel tentativo di essere, per un attimo e a caro prezzo, se stessi, a rischio di un gioco mortale. Oggi forse ci viene meno bene: ben vestiti o mal vestiti siamo seduti su un treno che ci porta dove vuole. Su questo treno nessun lanzichenecco salirebbe mai.




