Il centenario dell’assassinio del dirigente socialista Giacomo Matteotti (10 giugno 1924) da parte di un ‘commando’ fascista è stato l’occasione per una processione di articoli, interventi e saggi caratterizzati da un denominatore comune: la santificazione del martire della dittatura nel quale tutti gli antifascisti e i democratici possono identificarsi. Questo coro di omologazione di uno dei principali esponenti del socialismo riformista e democratico presenta però il difetto di mettere in ombra le specificità politiche e intellettuali del deputato del Polesine povero e contadino, vittima della sua intransigenza e del suo isolamento nell’ambito della stessa sinistra del tempo.
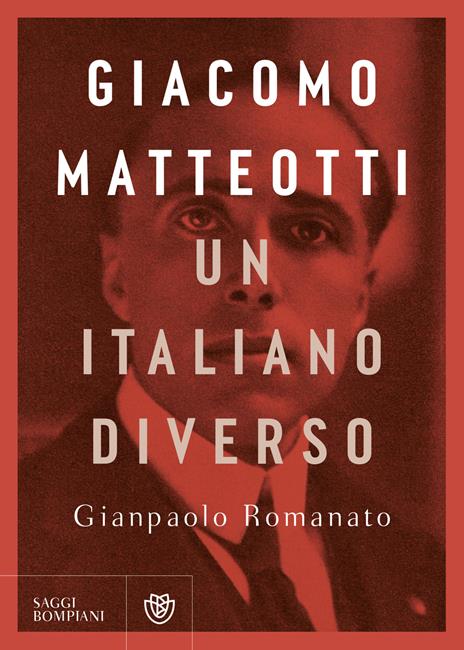
In controtendenza rispetto a questa operazione vale quindi la pena di segnalare l’uscita di un saggio di Gianpaolo Romanato che ci fa conoscere un altro Matteotti rispetto al santino buono per tutti i palati (Giacomo Matteotti. Un italiano diverso, Bompiani, 336. € 18,00). Romanato ricorda nell’introduzione che l’operazione di santificazione ebbe inizio quando ancora il corpo del leader assassinato non era stato ritrovato. In una lettera, Sandro Pertini lo definiva “il grande Martire” e il 27 giugno, durante una commemorazione, Filippo Turati parlando di Matteotti diceva: “Egli vive, Egli è qui presente e pugnace. Egli è un accusatore. Egli è un giudicatore.” “L’avello ci ha reso la salma. Il miracolo di Galilea si è rinnovato. Il morto si leva e parla…”. Un’orazione squisitamente religiosa, come osservò il sacerdote ex-modernista Ernesto Bonaiuti, a cui fecero seguito interventi indignati e commossi di esponenti della politica e della cultura non solo in Italia, ma anche in molti paesi europei e non solo. Se da vivo Matteotti era stato un avversario per il fascismo, da morto divenne un’ombra “inafferrabile e paurosa”, un testimone d’accusa contro il regime che non era possibile cancellare e che per alcune settimane successive al ritrovamento del suo corpo (16 agosto) rappresentò un serio pericolo per il regime.
La trasformazione dell’uomo politico in un mito ha reso però impossibile storicizzare la sua figura e la sua azione politica. Nel dopoguerra, scrive Romanato, Matteotti è diventato una icona da rispolverare nelle occasioni ufficiali in nome di un cordoglio unanime di facciata che ha impedito di approfondire la sua personalità, le sue idee e i contenuti delle sue battaglie politiche.

L’Autore ricorda che la bandiera del martire sventolata nelle celebrazioni non è stata a lungo una bandiera per tutti. Antonio Gramsci poche settimane dopo il funerale lo definì “pellegrino del nulla”. Tre anni dopo, la rivista del PCI “Lo Stato Operaio” scrisse che “Matteotti mancò come tutti i riformisti. La sua morte è stata quindi tanto più tragica perché segnò il fallimento della sua concezione, del suo partito, del suo metodo”. E Togliatti ammise con disappunto che la vittima più illustre del fascismo era stato un moderato, un “parlamentarista”, quasi un “reazionario” sul quale era opportuno stendere un velo di silenzio.
La verità che emerge da questo saggio è che Matteotti è stato un personaggio scomodo per i fascisti e per gli antifascisti. Per i primi è stato un nemico che non faceva sconti con i suoi interventi duri, polemici e documentati. Nei cinque anni tra il 1919 e il 1924 intervenne in Aula per ben 106 volte, fino alla seduta del 30 maggio del 1924, quando aveva guastato il clima di festa dell’apertura della nuova legislatura denunciando brogli e violenze e chiedendo l’invalidazione del risultato elettorale.
Ma era stato scomodo anche per tutte le sinistre, a cominciare dai comunisti, dopo la scissione del 1921, e dal gruppo dirigente massimalista del PSI, che inseguiva il mito della Rivoluzione d’Ottobre lanciando parole d’ordine incendiarie a cui non faceva seguito nulla sul piano pratico. Matteotti era così giunto alla conclusione che il bolscevismo, tanto caro alle sinistre estremiste italiane, era l’immagine speculare del fascismo: due dittature di segno diverso.
L’ultimo Matteotti è stato altrettanto duro nei confronti dei suoi compagni di partito, riuniti nel PSU dopo che nell’ottobre del 1922 la corrente riformista si era staccata dal PSI. Nelle lettere a Turati accusa di partito di nullismo politico, di cercare soltanto un accomodamento con il nuovo regime, di costituire insomma un piccolo esercito di vinti pronto soltanto alla ritirata.
Da queste osservazioni emerge il vero dramma di questo personaggio, individuato già da Piero Gobetti dopo il rapimento: la sua solitudine. Era un uomo solo che si trovava a portare avanti la sua battaglia intransigente tra rivoluzionari verbali e riformisti spesso tendenti all’opportunismo. E questo isolamento favorì la sua fine. Come scrisse Gaetano Salvemini alla vedova pochi giorni dopo la sua morte: “Se tutti avessimo fatto il nostro dovere, Egli non sarebbe stato ucciso”.




