Dan Diner racconta le settimane frenetiche del 1942 quando le armate tedesche erano a un passo dal futuro Israele. Uno sguardo inedito, da sud, sulla Seconda guerra mondiale
di Roberto Righetto da Avvenire del 18 agosto 2022
Cosa sarebbe accaduto in Palestina se nel 1942 le armate tedesche l’avessero conquistata? E quale destino avrebbero subito gli ebrei che l’abitavano e che meditavano di realizzarvi uno Stato? Dopo la disfatta britannica a Tobruch, ai primi di luglio, la Panzerarmee Afrika aveva preso Marsa Matruh avvicinandosi pericolosamente ad Alessandria e al Cairo, dove gli inglesi avevano iniziato a bruciare i documenti per evitare che finissero in mano nazista. Il catastrofismo s’impadronì in quei mesi degli ebrei che vivevano a Tel Aviv e Gerusalemme, sino ad allora risparmiate dalla guerra che imperversava in Europa e in Estremo Oriente. Fino al mese di novembre, con l’esito della seconda battaglia di El Alamein sfavorevole a Rommel e il rovesciamento di situazione verificatosi a Stalingrado, lo scenario della fine dello Yishuv, l’insediamento ebraico in Palestina durante il Mandato britannico, era ritenuto possibile. Tanto che l’Haganah, l’organizzazione paramilitare ebraica, ipotizzò un piano di suicidio collettivo sul monte Carmelo, dove centomila ebrei si sarebbero dovuti trincerare aspettando l’attacco tedesco: una sorta di “Masada bis” o una “Mussa Dagh ebraica”, come qualcuno la chiamò ricordando il sacrificio sotto l’impero romano e quello più recente degli armeni nel 1915, poco prima del genocidio compiuto dai turchi.
Il racconto di quelle settimane frenetiche è effettuato dallo storico Dan Diner in un saggio avvincente che mostra un aspetto sinora poco esplorato della seconda guerra mondiale: se di solito la prospettiva degli studi è stata prevalentemente orizzontale, con un’espansione che a partire dal 1939 dalla Germania ha riguardato l’Est e l’Ovest del Vecchio Continente, qui lo sguardo parte dal Sud del mondo per guardare a quanto accadeva a Nord. Tutta un’altra guerra. Il secondo conflitto mondiale e la Palestina ebraica (1935-1942) è il titolo azzeccato del volume tradotto da Bollati Boringhieri (pagine 320, euro 28,00).
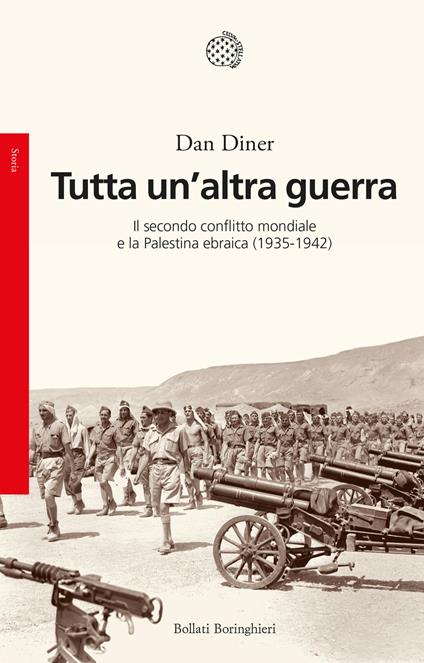
L’autore, nato a Monaco nel 1946 da immigrati lituani e polacchi, insegna Storia moderna all’Università ebraica di Gerusalemme e ha pubblicato varie opere sulla storia politica del XX secolo. In quell’estate Hitler era convinto che l’operazione Barbarossa si sarebbe presto conclusa con una vittoria schiacciante sull’Unione Sovietica. Ma un anno prima la direzione della Marina tedesca gli aveva suggerito di attendere ad aprire il fronte orientale e a privilegiare il terreno di scontro con Londra sul Mediterraneo e in Africa, arrivando così a conquistare il Vicino Oriente. «Una volta sospesi i preparativi per il piano, comunque altamente rischioso, di sbarcare sull’isola britannica nel settembre del 1940 – annota Diner –, il grande ammiraglio Raeder cercò di convincere Hitler che in quel momento si offriva l’occasione di sfruttare le debolezze britanniche nel teatro di guerra mediterraneo». Nel giugno del 1941 Raeder compì un ultimo tentativo di far rimandare l’offensiva orientale e di impadronirsi del Mediterraneo orientale, bloccando i rifornimenti attesi da Churchill che dovevano arrivare attraverso l’Oceano Indiano e il Mar Rosso. Per un certo periodo sembrò aver ragione il Fuhrer: «Nell’estate 1942 – rileva ancora Diner – la zona di dominio nazista aveva raggiunto la sua massima ampiezza, con l’avanzata dal deserto occidentale in direzione del Canale di Suez e la marcia attraverso la Russia meridionale in direzione del Caucaso e verso la foce del Volga. Tale espansione portò i vertici della Wehrmacht a crogiolarsi all’idea di una strategia in cui le due parti dell’esercito si muovevano l’una verso l’altra, chiudendosi a tenaglia: a sud dall’Egitto, a nord dal Caucaso. Il loro incontro, magari proprio nella zona della Palestina, avrebbe sottratto all’intero mondo britannico meridionale l’accesso alle fonti di carburante, interrompendo le vie di comunicazione e di trasporto vitali per l’impero, con conseguenze devastanti per la tenuta della Gran Bretagna». Un progetto bloccato pochi mesi dopo, sia in Africa che in Russia.
Ma com’era in quegli anni la situazione degli ebrei in Palestina? Rinvigoriti da un’immigrazione sempre più forte, proveniente da un’Europa dove la discriminazione verso gli ebrei era crescente, non solo in Germania ma anche in Polonia – qui maturò il progetto di trasferimento in massa in Madagascar -, l’ipotesi sionista prendeva sempre più corpo, nonostante l’opposizione dei britannici che volevano mantenere buone relazioni con i popoli arabi. Nel 1935 erano stati 60mila gli ebrei arrivati in Palestina. E il 16 ottobre di quell’anno accadde un episodio che avrebbe dato il via a una rivolta araba durata tre anni e piegata dai britannici con l’uso di una forza bruta. In una nave cargo belga, durante un controllo dei portuali arabi, furono ritrovati 360 barili contenenti armi destinate pronita babilmente agli ebrei. Da lì partì uno sciopero con proteste e gesti di violenza, tanto che i circa 7mila ebrei che abitavano nella città portuale dovettero abbandonarla. Quando nell’estate 1942 la Palestina era minacciata dal Terzo Reich, molti ebrei paventavano pogrom da parte araba nel caso di una vittoria dell’Asse sugli Alleati; ma ci fu anche chi meditò di affidare i propri figli ad amici arabi. La convivenza fra ebrei ed inglesi sin dall’inizio del Mandato britannico, nel 1920, non era stata affatto idilliaca. La famosa dichiarazione di Balfour del 1917, in cui il governo di sua maestà si impegnava a sostenere la creazione di una ‘dimora nazionale ebraica’ in Palestina, sarebbe stata di ben difficile attuazione, anche per le promesse precedenti fatte agli arabi. Lo stesso movimento sionista, come ben documenta Diner, aveva perso fiducia nell’impero, e nel maggio 1942, in un raduno straordinario tenutosi all’hotel Biltmore di New York, si era compiuta una vera e propria svolta: gli ebrei si sarebbero affidati alla potenza americana per raggiungere i loro obiettivi. Svolta che era coincisa con la perdita di consenso dell’allora presidente dell’Organizzazione sionista mondiale, Chaim Weizmann, considerato l’erede di Theodor Herzl, a favore di Ben Gurion, che era a capo dell’Agenzia Ebraica. In quell’albergo costruito a fianco della Grand Central Station e che sarebbe poi stato abbattuto, si verificò dunque una « translatio imperii dalla Corona Unita agli Stati Uniti» e si prospettò la creazione di un esercito ebraico che combattesse a fianco degli Alleati, per poter partecipare alla conferenza di pace che si sarebbe svolta alla fine della guerra. Prospettiva allora solo auspicata, dato che anche il vicepresidente Usa Wallace intervenendo al raduno ipotizzò almeno due anni perché la macchina bellica americana potesse entrare in azione al cento per cento.
All’incontro newyorchese fece capolino pure la questione dell’Olocausto, a quel tempo in gran parte sottostimato. Weizmann parlò chiaramente del destino tragico degli ebrei europei, facendo addirittura la previsione che sotto il dominio nazista il 25 per cento non sarebbe sopravvissuto. Vi fu chi gridò allo scandalo ma anche chi fece previsioni ancora più cupe. E in Palestina cosa si sapeva della Shoah? Solo a partire dalla metà di novembre 1942, con un gruppo di ebrei cittadini palestinesi provenienti dalla Polonia in un’operazione di scambio con prigionieri tedeschi, si cominciò ad averne notizia. Quei sopravvissuti alla macchina di sterminio nazista parlarono delle camere a gas e a stento furono creduti. Il 26 novembre l’Agenzia ebraica diramò un comunicato in cui si denunciavano le atrocità di Hitler nei campi nazisti in Polonia, dove trovavano la morte gli ebrei dell’Europa occidentale e orientale. Fu così la prima volta che lo Yishuv fece i conti con l’enormità della catastrofe.


