Un nuovo saggio racconta i primi vagiti di Roma, grazie anche alle ultime scoperte archeologiche che sempre più stanno confermando la realtà storica dei miti di fondazione
di Aldo G. Ricci da Storia in Rete n. 188
Da tempo gli scienziati s’interrogano, con risposte diverse, su cosa sia stato il nostro universo prima del big bang. Qualcosa del genere è avvenuto e avviene tra gli storici sulla nascita di Roma e su quale siano stati i passaggi e le componenti attraverso le quali si è giunti a quel risultato straordinario che è stata l’Urbe millenaria. Insomma «Roma prima di Roma», come recita il titolo dell’appassionante saggio di Gianluca De Sanctis, docente di Storia romana con all’attivo numerosi saggi dedicati alla città eterna. Come avverte l’autore nella premessa, per i Romani esiste un rapporto organico tra i racconti della fondazione (e anche i relativi miti) e i luoghi in cui essa è avvenuta. «I luoghi diventano dei “ponti” tra il tempo del mito, nel quale l’evento è accaduto, e quello della storia nel quale si chiede all’evento di restare». L’evento mitico acquista così una presenza nella storia nel suo continuo e concreto svolgersi, diventa la continuità tra passato e futuro, «ma anche il nesso profondo tra memoria e “identità”».
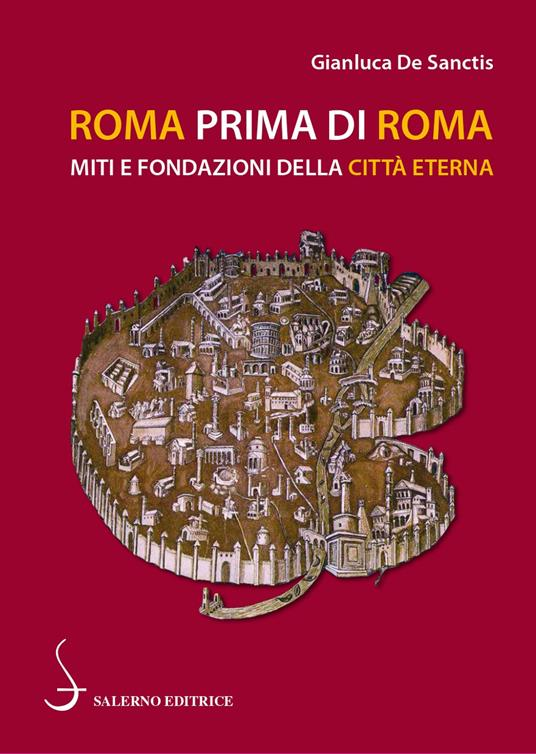
di Gianluca De Sanctis. Salerno editrice, pp. 250, € 20,00
L’identità, applicata al nostro tema, va spiegata, perché i Romani non avevano questa parola e, osserva De Sanctis, se avessero dovuto esprimerla forse avrebbero utilizzato il termine Roma, nel quale si riassumevano sia la città fisica che i suoi valori morali, politici e culturali, quei valori che avevano imposto a gran parte del mondo conosciuto l’Imperium, sintesi di potere, comando e territorio controllato e amministrato. Un potere che non significava esclusione delle popolazioni vinte, che anzi potevano essere assimilate se accettavano di entrare nell’universo della romanità, insomma se accettavano di farsi romani, con tutto ciò che ne conseguiva sul piano dell’integrazione culturale, politica e dell’osservanza delle leggi. A differenza dei Greci, per i quali l’identità era un fattore etnico, da rivendicare e difendere, per i Romani l’identità era aderenza a valori e modelli, apertura al diverso, che andava escluso quando poteva rappresentare una minaccia proprio a questa apertura. È evidente che lo studio della nascita di una città, e quindi di una civiltà, che per oltre mille anni ha monopolizzato il mondo ha da sempre affascinato gli studiosi che, fino a qualche tempo fa si sono divisi tra due diversi modelli interpretativi: quello della Stadtgrundung (nascita, creazione, fondazione) e quello della Stadtwerdung (urbanizzazione, sviluppo).
Secondo il primo modello la città sarebbe nata dalla fusione dei diversi villaggi che si trovavano sulla riva destra del Tevere, mentre per il secondo modello la città sarebbe stata l’espansione, lo sviluppo appunto, di una delle diverse comunità, in particolare quella che aveva sede sul complesso del Palatino-Velia. Tra i due modelli le differenze erano profonde. Mentre il primo era in qualche modo conciliabile con la tradizione letteraria, sia pure in senso lato, e presupponeva una rivoluzione, ovvero con un vero e proprio atto costitutivo, il secondo disegnava invece una lenta evoluzione e quindi una urbanizzazione progressiva dei diversi villaggi limitrofi. Il dibattito ha conosciuto una svolta in seguito ai risultati degli scavi trentennali alle pendici settentrionali del Palatino da parte del grande archeologo Andrea Carandini, presentati come la prova regina della fondazione di Roma, la «pistola fumante», come la definisce De Sanctis. Ma di che cosa si tratta? Dei resti di una struttura muraria lineare di circa 57 metri risalenti all’VIII secolo a.C., di un bastione quadrangolare agganciato alla parte più orientale e identificato con la porta Mugonia e di quattro sepolture a inumazione che, secondo i ricercatori, potrebbero risalire a sacrifici di carattere espiatorio. Il muro potrebbe essere identificato con quello eretto da Romolo a difesa della città da lui fondata. Naturalmente non sono mancate le riserve e le critiche, ma è innegabile che le scoperte abbiano «rilanciato su nuove basi il dibattito sulle origini di Roma» cercando di conciliare documentazione archeologica e tradizione letteraria: una tradizione sterminata se si pensa che esistono almeno una sessantina di versioni sulla nascita dell’Urbe.
Le più note sono certamente quelle di Livio, Plutarco, Varrone, che da Enea fuggito da Troia e rifugiato nel Lazio, attraverso Ascanio, approdano ai gemelli Romolo e Remo, fino all’uccisione di quest’ultimo per aver violato la sacralità delle mura e confermare così la supremazia della Legge. Nell’impossibilità di sciogliere definitivamente il nodo della fondazione, quello che conta, scrive De Sanctis, è che il mito «può aiutarci a capire le ragioni per cui i Romani hanno scelto di autorappresentarsi in questo modo e perché questa ricostruzione ha avuto la meglio sulle altre». Il perché, a questo punto, è evidente: era la ricostruzione che più corrispondeva alla vocazione di Roma in quanto città aperta all’integrazione, nata da eredi di esiliati e cresciuta sul diritto d’asilo, ma capace di chiudersi con durezza estrema contro quanti attentavano a questa sua natura potenzialmente universale.


