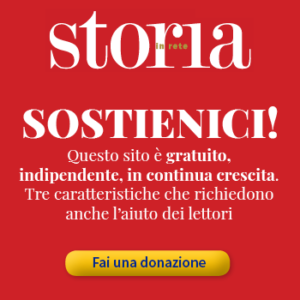Abbiamo chiesto a Giuseppe Parlato, lo storico che più si è occupato negli ultimi anni dell’esperienza del Movimento Sociale Italiano, di riesaminare alcuni degli snodi più importanti dei cinquant’anni di vita della Fiamma. Ne emerge un quadro molto articolato, ricco di chiari e oscuri. A cominciare dalla figura del leader missino più importante
di Fabio Andriola, dallo Speciale Storia in Rete n. 6
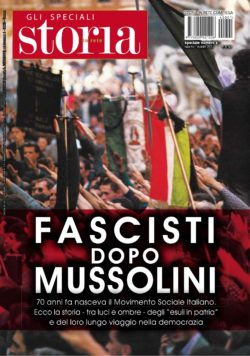
La Storia, paziente e sorniona, non ha paura del tempo, anzi… E così, senza fretta, arriva sempre a prendersi quello che le spetta. Anche da chi non ha fatto altro che correre, correre per lunghi decenni, per non farsi acciuffare, per non fare i conti col proprio passato. Cosa necessaria se si vogliono affrontare al meglio le sfide del presente e soprattutto quelle del futuro. Un certo mondo, quel mondo, non ha fatto nulla di tutto questo e i risultati si vedono. Nell’anno di grazia 2017 eccoci infatti a celebrare non un partito politico più o meno in salute ma comunque attivo e orgoglioso della propria, lunga e complicata, storia ma ben due defunti. Connessi tra loro, con vicende e dignità diverse, comunque uniti da un errore fatale e reiterato: non aver voluto – o creduto necessario – storicizzare davvero le proprie origini. Il Movimento Sociale – nonostante abbia avuto mezzo secolo di tempo a disposizione – non volle farlo con l’esperienza oggettivamente ingombrante del Fascismo; più modestamente (in tutti i sensi) Alleanza Nazionale in 14 anni non ha saputo far di meglio né col Fascismo né col MSI, di cui portava comunque la fiamma tricolore in grembo (e nel simbolo).
Da qualche anno, a mettere i fantasmi del MSI (e, in qualche modo, anche di An) di fronte alla propria storia terrena ci sta pensando Giuseppe Parlato, 64 anni, ordinario di storia contemporanea presso l’Università Internazionale di Roma, allievo e stretto collaboratore di Renzo De Felice, autore nel 2006 di un fondamentale saggio sulle origini del neofascismo italiano e quindi anche del MSI: «Fascisti senza Mussolini» (Il Mulino). È stato Parlato a curare la recentissima mostra per i 70 anni della fondazione del Movimento Sociale Italiano ed è sua la firma su un libro fresco di stampa («La Fiamma dimezzata», Luni editrice), dedicato ad uno dei momenti più controversi e drammatici della lunga storia missina: la scissione di Democrazia Nazionale, consumatasi nel dicembre 1976, pochi giorni prima che il MSI compisse i suoi primi trent’anni.
Due lavori “ravvicinati” ma molto diversi tra loro, soprattutto per l’impostazione. Giusto?
«In effetti con la mostra non ho voluto fare una storia del MSI ma cercare di illustrare il “vissuto” dei militanti missini. Come disse De Gasperi, il Movimento Sociale è stato un “partito dei sentimenti” e quei sentimenti abbiamo cercato di far rivivere, di rappresentare. E a giudicare dalla commozione di tanti visitatori direi che ci siamo riusciti… ».
Ma dalla sua analisi sembra di capire che l’aspetto “sentimentale” non riguardava solo la base del Movimento.
«Il MSI è stato un fenomeno originale, diverso da tutti gli altri partiti della Prima Repubblica perché fin dalla nascita volle essere, in un certo senso, “impolitico”. Non puntava – come naturale per ogni formazione politica – al potere, non prometteva neanche posti di lavoro ai suoi aderenti. Il MSI esiste dal primo giorno soprattutto per tramandare un’idea ed una identità sconfitte nella Seconda guerra mondiale».

Da quel “vizio” di origine discende tutta una serie di conseguenze…
«Esatto. A cominciare da un dibattito interno lungo decenni tra le due anime del partito. Da un lato c’è quella che potremmo definire la “destra nazionale”: cattolica, democratica, anticomunista, decisa a condizionare da destra la Democrazia Cristiana, disposta ad un accordo con i monarchici. E’ un’anima più politica in senso stretto ed è incarnata soprattutto da Arturo Michelini [segretario del MSI dal 1954 al 1968, NdR]. Dall’altro lato c’è la componente nostalgica, antisistema, che si richiama più direttamente alle pulsioni movimentiste, sindacali e antiborghesi del Fascismo, a lungo avversa ai monarchici. E qui il campione indiscusso è Giorgio Almirante…».
Ecco, fermiamoci un po’ su Almirante. Il suo giudizio su di lui potrebbe non piacere a più di un ex missino.
«Almirante è stato il maestro dei sentimenti in un partito “sentimentale”. Ha assecondato la visione politica dei militanti come visione sentimentale, usando sia il tasto della nostalgia sia quello del rancore. E poteva far questo meglio di chiunque altro perché nessuno, nel MSI, conosceva il partito come lui. Conosceva ogni sezione, ogni dirigente, era stato in ogni paesino, anche per incontrare un pugno di militanti, Non aveva la visione politica di Michelini ma seppe incarnare l’anima missina come nessun altro. Per certi versi è lui che inventa la politica spettacolo e incarna la personalizzazione della leadership: Almirante è l’MSI molto più di quanto De Gasperi sia stato la Dc o Togliatti il Pci. E lo è stato per la sua grande capacità di sollecitare i sentimenti e l’emotività della base»
Questo andava benissimo quando c’era da “scaldare” una piazza, Ma la politica è anche altro, no?
«Michelini, e la componente che si riconosceva in lui, cercava di uscire da questa gabbia sentimentale. Almirante in quella gabbia ci stava benissimo anche perché, tendenzialmente, il militante missino era più affine a lui che ai micheliniani. Ironia vuole che, nel 1969, Almirante succeda alla segreteria a Michelini già gravemente malato e lo fa grazie ad un accordo con la componente che fa capo all’ex segretario. In breve trasforma il partito e, grazie anche al rientro di Pino Rauti e del gruppo di Ordine Nuovo, fa emergere le varie anime del partito cui dare, alternativamente voce e mantenere il controllo: c’è la destra nazionale, ci sono i corporativisti, gli alfieri dell’alternativa al sistema. Un costante richiamo all’esperienza fascista senza però nessuna voglia di storicizzare quella esperienza. Anzi: la storicizzazione veniva apertamente indicata come una liquidazione del Fascismo».
E quindi, l’Almirante segretario nei terribili anni Settanta come pensa di fare politica?
«Almirante non ha una strategia precisa, ne ha due: proseguire nella politica della destra nazionale, aprendo ai moderati, e mantenere saldo il legame con la destra estrema, assecondando o non eliminando le posizioni più radicali. In realtà, punta ad uscire dall’isolamento con qualche colpo ad effetto. È così che nasce l’esperienza della destra nazionale, l’inclusione di monarchici e uomini di destra o “d’ordine”. Ma è un’esperienza che cozza con la volontà di mantenere viva – anche grazie al clima degli Anni di Piombo – l’ala militante del partito. Come si fa ad essere ad un tempo partito d’ordine e movimento muscolare? A questo si aggiunga che dopo l’exploit elettorale di inizio anni Settanta, a metà del decennio le urne non danno più risultati esaltanti. Per cui si imponevano delle scelte strategiche»
E qui si arriva alla scissione di Democrazia Nazionale?
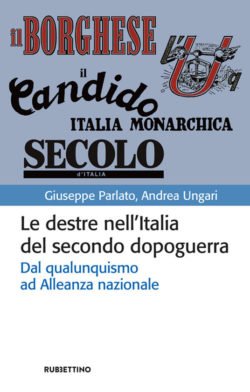
«Infatti. Una scissione che non fu voluta e ispirata dalla Dc come Almirante volle far credere. Anzi, la Dc non aveva interesse e, comunque, se avesse voluto avere un ruolo l’avrebbe fatta meglio. Dalle mie ricerche emerge chiaramente che fu lo stesso Almirante a spingere fuori dal partito De Marzio e gli altri per sciogliere, una volta per tutte, l’equivoco delle due anime del MSI. Quella che esce è, di fatto, la componente micheliniana che non ha capito, al contrario di Almirante, una cosa fondamentale…»
E cioè?
«E cioè che Almirante conosceva così bene il Partito da sapere che non poteva diventare, da partito di militanti qual era, un partito d’opinione e dare voce compiutamente alla famosa “maggioranza silenziosa”, la parte di elettorato moderata, conservatrice, anticomunista che alla fine finiva sempre per votare Democrazia Cristiana. Un partito d’opinione si sarebbe esposto ad inevitabili alti e bassi nei consensi: Almirante preferisce tenersi la base, ridotta ma sicura, dei militanti. Il MSI torna ad essere soprattutto un partito di testimonianza. Probabilmente, così facendo, scegliendo la militanza, Almirante salva il partito ma ha contribuito a non far sviluppare in Italia le radici di una destra di governo. Come poi si è ben visto negli anni Novanta…».
Perché, comunque, l’esperienza di Democrazia Nazionale fallisce così rapidamente?
«Per vari motivi. Nonostante i vertici di Democrazia nazionale fossero composti da personaggi intellettualmente e culturalmente di gran livello, non capirono alcune cose. In primis che la base non li avrebbe mai seguiti. E poi che in un contesto di piena Guerra fredda, i tempi non consentivano sdoganamenti indolori per chi veniva dal Fascismo e non intendeva certo sconfessarlo o rinnegarlo ma semplicemente storicizzarlo. Restano in qualche modo in mezzo al guado: non abbastanza fascisti per i missini, troppo fascisti per i partiti dell’arco costituzionale. Non avevano dietro né la Dc, purtroppo per loro, né i cosiddetti “poteri forti”. Infine non avevano un vero leader. Mentre dall’altra parte c’era Almirante».
Possiamo dire che Alleanza Nazionale nel 1995 è stata quello che Democrazia Nazionale non poté essere vent’anni prima?
«Non esattamente. Indubbiamente c’è l’elemento importante della volontà di collegare le destre in Italia. Ormai la Guerra Fredda era finita e quindi il quadro internazionale era più favorevole ad operazioni di questo tipo. Ma mentre Democrazia Nazionale era parte della storia del MSI, ne incarnava una delle anime originarie, e fu il frutto di una lunga gestazione culturale e politica, Alleanza Nazionale venne concepita “a freddo”, in laboratorio, in pochi mesi. E questo spiega il rapporto superficiale, infastidito, col proprio passato. Non ci fu neanche quella volta la storicizzazione né del Fascismo – liquidato come “Male assoluto” e con l’inserimento un po’ surreale di alcuni nomi storici dell’antifascismo tra le figure d’ispirazione della nuova formazione – né dell’esperienza dell’MSI».
Vogliamo provarci qui? Che bilancio si può dare dei cinquant’anni del MSI?
«Il Movimento Sociale ha svolto sicuramente un ruolo nel sistema democratico italiano del dopoguerra. Ad esempio ha assorbito l’eversione nera nei primi anni, incanalando il revanchismo fascista che altrimenti si sarebbe potuto rivelare destabilizzante per la neonata Repubblica. C’è poi quella “delegittimazione legittimante” che prese corpo nel sistema dei partiti: per la Dc il MSI nella sua versione muscolare e nostalgica è stata una manna perché le ha consentito di presentarsi come la casa naturale dei moderati; per il Pci l’MSI è stato non meno utile perché legittimava e giustificava l’antifascismo come elemento fondante della Repubblica. Come ci si poteva dire antifascisti senza un partito neofascista? D’altra parte è anche vero che senza il MSI certe derive di sinistra e di ultra sinistra, politiche e di piazza, sarebbero state sicuramente molto più gravi e accentuate. L’equilibrio della Prima Repubblica poggiò anche sul sacrificio di tanti militanti missini».