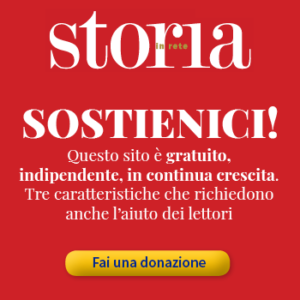Difficile che fosse Mussolini come sostengono gli autori di “Nero di Londra” convinti che il futuro Duce nel gennaio 1918 finì sul libro paga dei servizi inglesi. Per far cosa? Esattamente quello che faceva già dall’autunno 1914: propaganda per la guerra contro Germania e Austria. Abbiamo riletto con attenzione questo saggio ricco di documenti ma fragile sul fronte della loro interpretazione e contestualizzazione. Come dimostra il caso dell’attribuzione di un nome in codice… (da Storia In Rete n. 196, marzo-aprile 2023)
Questo articolo avrebbe voluto essere un’intervista. Infatti, prima di cambiare idea Giovanni Fasanella, autore con Mario José Cereghino del fortunato “Nero di Londra” (Chiarelettere), si era detto disponibile a rispondere alle nostre domande. Domande non di comodo perché, ad una attenta lettura, il libro che intende svelare come «l’intelligence militare britannica creò il fascista Mussolini» mostra, a nostro giudizio, limiti che finiscono per inficiarne radicalmente la tesi di fondo. Quale tesi? Una “cosetta da niente” e cioè che l’ascesa di Mussolini, la marcia su Roma e la sua successiva affermazione come dittatore d’Italia sarebbero stati finanziati e appoggiati per decenni dalla Gran Bretagna, segnatamente dalla classe dirigente conservatrice inglese che aveva la sua longa manus soprattutto nei servizi segreti militari e nella diplomazia. Un sostegno che sarebbe andato dal gennaio 1918 al 1939, anno dello scoppio della Seconda guerra mondiale e vigilia dell’ingresso nel conflitto dell’Italia (10 giugno 1940). Come per certe serie tv di successo, Fasanella e Cereghino con “Nero di Londra” hanno scelto la carta del “prequel”. Hanno cioè deciso di raccontare gli antefatti della storia che stanno ricostruendo da anni in vari libri – soprattutto l’eccellente “Il Golpe Inglese” (Chiarelettere, 2014) e “Colonia Italia” (Chiarelettere, 2019) – e cioè le storiche e pesanti ingerenze politiche, economiche, culturali e militari di Londra sul “sistema Italia”. Un approccio interessante, controcorrente, sostenuto da documenti per lo più inglesi, e che meriterebbe maggior attenzione da parte della classe dirigente e intellettuale italiana, purtroppo afflitta, come si sa, da una esterofilia che la rende ancora più miope di quanto non sia già di suo.
Che gli inglesi, durante la Prima guerra mondiale, abbiano osservato con attenzione le vicende interne italiane non può certo stupire. E che a quell’attenzione possano essere seguite azioni concrete di finanziamento, di pressione politica o altro è nella logica delle cose. Quello che stona è invece il convincimento che al centro di quell’azione, per anni, ci siano stati Mussolini e il movimento fascista. Ora è certo che fin dal 1914, per dar vita al suo quotidiano “Il Popolo d’Italia”, Mussolini accettò finanziamenti da numerose fonti: dalla grande industria nazionale alla massoneria francese (per conto del governo di Parigi), dai servizi zaristi ad ambienti governativi romani, giusto per citare solo i principali elargitori di aiuti. Che a questa composita e ben nutrita pattuglia si siano aggiunti anche gli inglesi non può stupire. Casomai, ogni notizia di questo genere deve essere accompagnata dalla risposta ad una semplice ma fondamentale domanda: Mussolini accettò quel denaro per cambiare opinione oppure quel denaro gli arrivò perché aveva cambiato opinione? Tutti i rivoluzionari, per portare avanti i propri piani, si rivelano pragmatici e cinici. L’esempio di Lenin, aiutato dai servizi tedeschi per rientrare in Russia e metterla sotto sopra, è esemplare e tutt’altro che isolato. E certo non è un caso che, subito dopo la rivoluzione russa del ‘17, Lenin accettò le dure condizioni imposte da Berlino per la pace ad est, sancita a Brest-Litovsk il 3 marzo 1918.
Le ricerche di Fasanella e Cereghino aprono – anzi, riaprono visto che già nel 1978, Franco Bandini inserì in “Vita e morte segreta di Mussolini” (Mondadori) il capitolo “Sterline per un oscuro agitatore” – squarci interessanti sull’azione diplomatica e di intelligence inglese in Italia, specie dal 1917 in poi ma risultano poco convincenti quando forzano la documentazione a disposizione per sostenere che Mussolini venne avvolto nelle maglie della politica occulta britannica, diventandone di fatto, per anni, uno strumento. Ipotesi suggestiva che però cozza contro troppe obiezioni per riuscire ad essere, anche solo in parte, convincente. Tra le ragioni di questa fragilità c’è che Fasanella e Cereghino si basano su un fondo archivistico poco o punto esplorato fino ad oggi ma trascurano molti altri elementi – già acclarati dalla storiografia – che sarebbero stati utili per contestualizzare e contrappuntare quanto emerge dalla carte di Sir Samuel Hoare, agente dei servizi segreti militari durante la Grande Guerra (prima in Russia, poi in Italia) e in seguito diplomatico e uomo di governo britannico. Hoare era un conservatore e il dettaglio è importante perché prima di entrare nel merito dei documenti reperiti in Inghilterra, Cereghino e Fasanella fanno un ampio preambolo (circa 50 pagine su 230 di testo) per raccontare di due libri usciti in Gran Bretagna, entrambi scritti per accusare la classe politica conservatrice britannica di aver aiutato, tollerato se non agevolato il regime fascista italiano. Rileggendo Guilty Men (dell’estate 1940) e The Trial of Mussolini (del 1943, pubblicato poi in Italia nel dopoguerra col titolo “Un inglese difende Mussolini”), instant-book dietro i quali si celava un giovane giornalista laburista, Michael Foot, si ha un’idea dell’approccio “morbido” che a lungo i conservatori inglesi ebbero verso il Duce. Infatti, i due volumi sono costruiti sulle tantissime dichiarazioni di esponenti del governo e della politica di Londra, dichiarazioni ancora oggi sorprendenti per i toni encomiastici e per lo spettro temporale che coprono, dagli anni Venti alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, un conto sono le simpatie – sincere o di convenienza – tra politici, un altro sono i legami occulti – non solo economici – che possono legare un personaggio pubblico ad un servizio d’informazioni straniero. Puntare su questo secondo aspetto è un azzardo ma è quello che fanno con slancio Fasanella e Cereghino, prigionieri del teorema che anima il libro e che ne ha fatto la fortuna editoriale, almeno nel breve periodo. Retrodatando poi l’effetto e l’origine di gran parte delle citazioni contenute nei due libri infatti i due autori arrivano a sostenere addirittura che la carriera del Duce tra il 1917 e il 1922 «non avrebbe preso la strada che conosciamo senza l’influenza del partito conservatore britannico».
Difficile condividere tanta sicurezza di giudizio anche perché, in questo teorema, troppe cose non reggono al confronto con quanto ormai si può considerare acclarato storiograficamente. A cominciare dalla cronologia e dalla contestualizzazione temporale. Un “difetto” che emerge subito, dall’esame dei primi documenti provenienti dall’archivio Hoare e che risalgono all’epoca del suo arrivo in Italia, nell’estate 1917: gli autori di “Nero di Londra” attribuiscono all’intelligence britannica l’ambizioso piano – The Project – di mantenere l’Italia nell’Intesa con inglesi e francesi e “disarticolare” il partito tedesco che in Italia poteva contare su importanti appoggi e interessi, a cominciare da ambienti vaticani e finanziari. Che gli inglesi avessero un obbiettivo simile è possibile e legittimo ma è curioso pensare che lo facessero per conto proprio, in un paese alleato dove la corrente anti-tedesca era già fortissima da ben prima dello scoppio della guerra. Insomma, gli italiani del 1917 non avevano certo bisogno di attendere gli inglesi per condurre una battaglia che non era solo militare ma anche economica, culturale e giornalistica. Fronte, quest’ultimo, sul quale dal novembre ’14 attivissimo era proprio Mussolini col “Popolo d’Italia”. Ugualmente, quando l’Italia vive i drammatici giorni di Caporetto, a leggere “Nero di Londra” sembra quasi che la nazione regga la botta per il gran lavorio fatto dagli agenti inglesi. Si legge infatti a pag. 88 a proposito di Hoare, in Italia da circa 4 mesi: «Che cosa percepiva in tempo reale, grazie alle sue fonti di primissima mano, su ciò che stava accadendo? E in che modo cercava poi di governare gli eventi, nel tentativo di indirizzarli verso esiti favorevoli agli interessi dell’establishment britannico?».
Le risposte a queste domande sono nei documenti del fondo Hoare a cui Fasanella e Cereghino attingono a piene mani leggendoli però senza dare il giusto peso alle parole con cui Hoare riferisce a Londra le sue analisi sulla situazione italiana. Da buon inglese, Hoare non sembra capire molto la situazione italiana che finisce per essere filtrata dai soliti cliché acuiti da un insopprimibile senso di superiorità che inevitabilmente sfocia nella superficialità nei giudizi. Lo spauracchio dei britannici sembra essere Giovanni Giolitti, capo del “partito pacifista” ed eminenza grigia della politica italiana: ogni “sbandata” del Regno d’Italia, visto come l’anello debole della Triplice Intesa che combatteva gli austro-tedeschi, riporterebbe a lui e ai suoi uomini, sparsi un po’ ovunque. La “profondità di analisi” degli uomini di Londra è attestata, ad esempio, da un rapporto del 25 ottobre 1917 in cui, riferendo sulla rotta di Caporetto a Londra, l’ufficio romano del Directorate of Military Intelligence (DMI) mette in relazione il primo cedimento del fronte italiano col fatto che in quel settore operava un reparto di soldati piemontesi quindi potenzialmente “giolittiani” e, di conseguenza, tendenzialmente filotedeschi in quanto come è noto l’ex primo ministro Giovanni Giolitti, cuneese, si era speso per tenere l’Italia neutrale! A confermare un certo strabismo britannico nell’ interpretare la realtà italiana c’è l’assoluto silenzio su come l’intera nazione, nelle settimane successive a Caporetto, abbia rapidamente reagito gettando le premesse per la vittoria schiacciante di esattamente 12 mesi dopo. Una reazione simboleggiata dalla fermezza di Vittorio Emanuele III nel convegno inter-alleato di Peschiera e dal nuovo governo Orlando che diede un chiaro segnale soprattutto agli alleati franco-inglesi, desiderosi di commissariare l’Italia per evitare ulteriori crolli. Che non ci furono nonostante l’apporto militare franco-tedesco sia stato poco significativo. Eppure, gli inglesi guardavano con sospetto pure il neo Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, considerato non solo troppo vicino – pure lui – a Giolitti ma anche “sospetto” perché teneva per sé il ministero dell’Interno, considerato «un covo di filotedeschi». Di fronte a questa situazione giudicata a Londra – grazie anche a Hoare e ai suoi rapporti – molto rischiosa, si decide di correre ai ripari. Come? Facendo leva su gruppi e personaggi con pochi scrupoli e molti bisogni economici per compattare il “fronte interno” e consentire all’Italia di reggere e continuare ad impegnare il più possibile gli austro-tedeschi.
A quali gruppi si sarebbero rivolti gli inglesi? All’immancabile Massoneria e poi a interventisti, reduci e nazionalisti riuniti nelle influenti organizzazioni dei Reduci e Mutilati e degli Arditi. Sulla fondatezza delle considerazioni contenute in “Nero di Londra” a proposito del presunto ruolo svolto dalla Massoneria in combutta con gli inglesi ha già scritto su “Storia In Rete” n. 195 (novembre-dicembre 2022) Aldo Mola sottolineando gli errori di prospettiva e di analisi che fece a suo tempo Hoare e con lui, oggi, Cereghino e Fasanella. I quali enfatizzano ad esempio ruolo e azione di Luigi Resnati, promosso indebitamente esponente di punta del Grande Oriente d’Italia (GOI) mentre da questa “obbedienza” era stato espulso, seguito solo da circa 200 “fratelli”, cioè lo 0,5% degli aderenti al GOI. Parlare a questo punto di Massoneria coinvolta appieno nel britannico “The Project” tra il 1917 e 1918 è, per lo meno, avventuroso. Come lo è, in fondo, voler far entrare in questa ricostruzione anche Mussolini, per lo meno con un ruolo che difficilmente può essere stato il suo nei termini suggeriti da “Nero di Londra”. Il nome del futuro dittatore ricorre nelle informative degli inglesi: ma sono, appunto, informazioni e analisi senza cenni diretti ad un coinvolgimento del direttore de “Il Popolo d’Italia” nell’apparato d’intelligence britannico. Nella sua recensione sul “Corriere della Sera” del 28 ottobre 2022, Ferruccio Pinotti è su questo punto molto chiaro: «I dispacci inviati da chi all’epoca relazionava ai vertici dell’intelligence inglese mostrano un grande interesse per l’evolversi della situazione italiana e una sostanziale “neutralità” nei confronti di Mussolini, visto senza astio ma nemmeno con un appoggio aperto. Le relazioni inviate a Londra si attengono ai fatti, non si spingono a suggerire operazioni per ostacolarlo». Come trovare allora le prove che Mussolini era diventato, con tanto di nome in codice – The Count – un agente britannico? Semplice: le prove non ci sono. Fasanella e Cereghino le sostituiscono con alcune supposizioni che, ai loro occhi, diventano magicamente certezze, a partire da pag. 118 dove si legge, in riferimento alla situazione italiana del gennaio-febbraio 1918: «Ed è a questo punto che nei rapporti dei servizi militari inglesi compare per la prima volta un misterioso personaggio. Il suo nome in codice è “The Count”, il Conte. Chi è? Nessuna certezza matematica, anche se possibile azzardare un’ipotesi alquanto precisa sulla sua identità». L’ipotesi si basa su un telegramma del 2 febbraio 1918 inviato dall’ufficio DMI di Milano a Londra, nel quale si riferisce che i britannici avrebbero chiesto a “The Count” di intervenire sulle associazioni di reduci e mutilati perché non si facesse ricorso alla violenza contro socialisti e pacifisti e fare così «il gioco del nemico». E chi, se non Mussolini, sostengono i due autori, poteva avere l’autorità sufficiente per imporsi sugli agguerriti gruppi dei reduci e dei mutilati? Un’illazione non suffragata da nessun documento concreto. Benché molti altri personaggi potessero, in quei mesi, avere voce in capitolo nel mondo dell’interventismo, Cereghino e Fasanella, nella pagina successiva, hanno già saltato il fosso che separa il Dubbio dalla Certezza: poiché in quei giorni la propaganda mussoliniana a favore della guerra è “decisamente vigorosa” allora si può concludere che «“The Count” e Mussolini sono la stessa persona? A questo punto è più di un’ipotesi». Del resto, in un altro documento inglese di quei giorni, si accenna forse al fatto che «“The Count” utilizza il nostro denaro per i giornali»? Quindi, poiché Mussolini ha un giornale – come se fosse l’unico foglio a favore della guerra… – ecco che il teorema ha la sua dimostrazione. Già, ovviamente c’è del denaro in ballo. Ma quanto? I documenti parlano di 50 sterline al mese destinate a “The Count”. Al cambio attuale, 50 sterline del 1918 corrispondono a qualche migliaio di euro: tre/quattro mila? Forse qualcosa di più? Comunque l’ordine di grandezza è questo. Da qui la domanda (nostra): ma un giornale che vendeva tra le 30 e le 60 mila copie (fonte sempre le informative inglesi) come poteva essere condizionato con una somma che avrebbe potuto coprire, forse, le spese mensili di cancelleria?
Ma la china presa da “Nero di Londra” è questa: i primi finanziamenti a “The Count” vengono autorizzati da Londra il 29 dicembre 1917 ed elargiti solo il mese seguente. Cioè, sempre in teoria e per seguire il ragionamento dei due autori, Mussolini avrebbe continuato a fare quello che faceva dal 1914 ricevendo, dal gennaio 1918, 50 sterline al mese. Questo lo avrebbe reso uno strumento privilegiato della propaganda inglese prima e in seguito, addirittura, della politica d’influenza di Londra? A pagina 120, gli autori rispondono, sicuri, di sì perché “The Count” non può essere che Mussolini: «Un personaggio che esercita un ascendente fortissimo sulle organizzazioni paramilitari, impegnato nella propaganda attraverso i giornali e stipendiato direttamente dal Secret Service inglese, in modo che nessuno possa risalire al Dmi romano al comando del tenente colonnello Samuel Hoare: chi se non il futuro duce?». Stabilito che “The Count” e Mussolini sono la stessa persona la strada si fa in discesa e non ci sono altri ostacoli nella comprensione dei piani inglesi in Italia tramite il nuovo uomo-chiave: «All’inizio del 1918, in pratica, Sir Hoare porta a termine la “transazione” con Mussolini, che è ormai un “asset” con tanto di nome in codice – “The Count”-, una “risorsa” fondamentale per le strategie di lungo periodo dell’entità spionistica antesignana dell’MI6».
Più interessanti certe dichiarazioni di Hoare di molti anni dopo, nelle quali accenna a contatti con Mussolini durante l’ultimo anno della Grande Guerra ma anche qui molte cose non tornano visto che il diplomatico inglese insiste a dire di aver “convinto” Mussolini a sostenere gli Alleati quasi che il futuro capo del Fascismo avesse bisogno di essere convinto a seguire una strada che aveva imboccato già da anni. Anche sui finanziamenti c’è solo un accenno ma, come si è detto, che soldi al “Popolo d’Italia” siano arrivati pure da Londra non è una gran notizia, trattandosi comunque di uno dei tanti rivoli che alimentarono la vita, spesso stentata, del giornale mussoliniano. Resta indimostrato come e quando Mussolini sia stato assoldato dai servizi di Sua Maestà col nome in codice di “The Count”. Cereghino e Fasanella ne sono certi ma ci sono ottime ragioni per credere l’opposto. In primis, almeno tra i documenti citati, i riferimenti diretti e circostanziati a “The Count” sono pochissimi quindi difficile cercare riscontri temporali. Lo si può fare solo in un caso: a pag. 123 si legge che il cap. Woodrow del Dmi scrive da Milano a Roma il 15 aprile 1918 per informare che «rientrerà a Roma in compagnia di “The Count”». Però sappiamo per certo che da prima dell’11 e almeno fino al 14 aprile Mussolini era già a Roma (il 13 aveva incontrato il generale Cadorna). In una lettera alla sorella Edvige, Benito scriveva l’11 aprile: «Mi trovo a Roma da qualche giorno…» e che «tornerò a Milano sabato o domenica» (sabato era il 13 e domenica era il 14 aprile). Possibile che, appena arrivato a Milano, il 14 aprile abbia già parlato con Woodrow dicendogli che lo avrebbe accompagnato a Roma, da cui era appena rientrato? Oltretutto sappiamo che in quei giorni, Mussolini era in agitazione perché la moglie Rachele doveva partorire da un giorno all’altro il loro terzogenito (Bruno, poi nato il 22 aprile 1918) e quindi si muoveva da Milano mal volentieri. L’unico riscontro possibile porta quindi ad escludere che Mussolini fosse “The Count” visto che di certo Mussolini rientrò da un soggiorno romano di giorni il 14 aprile ed è improbabile che vi volesse tornare a distanza di un giorno o due. Oltretutto all’epoca per il tragitto Milano-Roma non c’era il Frecciarossa e il tempo necessario superava tranquillamente le 10 ore…
Ma c’è un altro riscontro che cozza con la tesi di “Nero di Londra”: il programma dei Fasci di Combattimento fondati da Mussolini nel marzo 1919. In cosa quel programma poteva piacere ad un conservatore inglese? Alla luce degli enunciati sansepolcristi del 23 marzo ’19 come si può pensare che Mussolini si muovesse per favorire gli interessi britannici? E ancora: il lungo passaggio di Mussolini e del suo movimento dall’irrilevanza all’ingresso in Parlamento, sia pure all’opposizione – quasi due anni – non è stato segnato da così tanti eventi, anche di natura molto diversa gli uni dagli altri, che vedervi una regia inglese sia un po’ azzardato? E infine, come si può sostenere – come pure si fa nel libro – che la Marcia su Roma sia stata pesantemente condizionata e favorita dai soliti britannici in quanto i quadrumviri incaricati di guidarla da Perugia, si appoggiavano, oltre che al noto Hotel Brufani, anche alla casa di Adriano Gallenga Stuart, un italo-inglese, ex deputato liberale passato al Partito fascista nel 1921, da tempo tra gli informatori di Hoare? La tentazione di trasformare una congettura in una importante tessera del puzzle porta gli autori di “Nero di Londra” a forzature davvero bizzarre. Ad esempio, a loro giudizio, è significativo il fatto che Mussolini, da presidente del Consiglio, sia andato a vivere a Palazzo Tittoni, in via Rasella a Roma, che è a poche decine di metri dalla sede dei servizi inglesi, in via delle Quattro Fontane. Ma la vicinanza geografica cosa può dimostrare? Come la si può considerare determinante viste tutte le possibilità di contatto alternative che ci potevano essere? Con la stessa logica si potrebbe argomentare che, con il trasferimento a Villa Torlonia nel luglio 1925, i rapporti Mussolini-Londra entrarono in grave crisi visto che il Duce si era allontanato di oltre tre chilometri…
Più interessanti e circostanziate sono le gravi notizie che il libro offre su Francesco Saverio Nitti, nel 1918 ministro del Tesoro, che avvicinò gli inglesi direttamente. Curiosamente per lui non ci sono nomi in codice e supposizioni: eppure non è un semplice giornalista ma un ministro che nel giugno 1919 diventa addirittura Presidente del Consiglio. Nitti avrebbe chiesto agli inglesi “assistenza” per un suo personale servizio di informazioni. Ma la domanda è: come è possibile che da Londra si pensasse di manovrare ad un tempo due personaggi antitetici, rappresentanti di visioni opposte dell’Italia e del suo ruolo oltre che divisi da un odio personale e politico, come Nitti e – forse – Mussolini? “Nero di Londra” non lo spiega mentre dedica molte pagine ad un’altra questione che legherebbe il Mussolini dei primi anni Venti ai servizi inglesi e cioè i dossier che prima di morire Giacomo Matteotti aveva raccolto contro il governo Mussolini e che sarebbero stati presi, al momento del rapimento, dal capo della spedizione punitiva, il fascista fiorentino (ma di madre americana) Amerigo Dumini per poi ricattare per vent’anni Mussolini. Una lettura del delitto Matteotti messa radicalmente in crisi dai lunghi studi del professor Enrico Tiozzo a cui “Storia In Rete” ha dato ampio spazio. Purtroppo in “Nero di Londra” non c’è traccia di quell’enorme lavoro basato esclusivamente su documenti e atti processuali.
“Nero di Londra” è stato un caso editoriale nel 2022 anche perché, forse ben oltre le intenzioni degli autori, la sua tesi di fondo è di fatto funzionale al mainstream storico-divulgativo, sempre più orientato a demonizzare piuttosto che a spiegare e argomentare su solide basi logiche ancor prima che documentali. Cattiva fede e bava alla bocca non fanno però parte del repertorio di Cereghino e Fasanella che, comunque, a differenza di molti altri la fatica di andare negli archivi la fanno. Uno sforzo che in questo caso è stato messo però al servizio di un teorema difficile da dimostrare in modo inoppugnabile e basato sulla improbabile equazione “Mussolini = The Count”. L’equivoco di metodo che penalizza il libro è cercare una proiezione di lungo periodo nei contatti tra Mussolini e gli inglesi in un’ottica di sudditanza del primo verso i secondi. A pag. 60 si legge che, se esaminati prima, i documenti di Hoare avrebbero consentito di «sciogliere il rebus dei rapporti di lungo periodo tra Mussolini, l’establishment conservatore britannico e i servizi d’intelligence di sua maestà». Se i rapporti sono stati indiscutibili, almeno a livello politico e di diplomazia segreta, per inquadrarli correttamente si deve però distinguere, da un lato, tra gli abituali contatti riservati tra Stati o le possibili coincidenze di interessi, anche momentanee, tra grandi potenze e, all’opposto, il controllo di una sull’altra, un po’ sullo stile di certe dittature sudamericane in balia degli Usa. Confondere i due livelli risulta fuorviante anche perché, alla fine, come spiegare la guerra nel 1940?