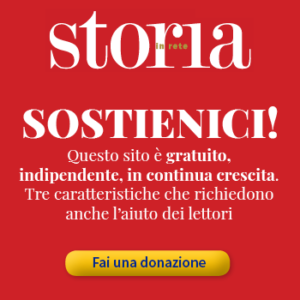Continua la serie di articoli nati per approfondire il tema dei bombardamenti alleati sull’Italia ispirati a un passaggio della prima puntata del podcast Una mattina de Il Post. Qui il primo articolo, in questa seconda puntata il tema sono i bombardamenti su Napoli.
Da un passaggio del podcast «Dopo che nel 1942 gli inglesi avevano sottratto il controllo della Libia all’esercito fascista i bombardieri partono da lì dalla Libia, oppure da Malta e sganciano tonnellate di esplosivo sulla città italiana e poi tornano» sembra quasi che il ruolo della Libia liberata dalle forze dell’Asse fosse stato determinante per i bombardamenti sull’Italia.
Nel primo articolo abbiamo visto come il Bomber Command della Royal Air Force britannica potesse operare contro Genova, Torino e Milano fin dall’entrata in guerra dell’Italia. In questo secondo articolo ci concentriamo sul meridione e, in particolare, sul caso di Napoli.
Ovviamente il centro e il sud Italia non erano raggiungibili dall’Inghilterra, ma erano nel mirino dei bombardieri che operavano dalla piazzaforte di Malta, come ricorda anche il podcast citato. Anche in questo caso una base disponibile fin da subito per la Royal Air Force, pur con diverse limitazioni legate alla quantità e tipologia di velivoli disponibili. E alle possibilità delle piste maltesi.
I primi Wellington a Malta
All’entrata in guerra dell’Italia a Malta non sono disponibili bombardieri. I primi ad arrivare sono i Vickers Wellington del 148° Squadron che arrivano sull’Isola del Mediterraneo direttamente dall’Inghilterra. Ma le limitazioni sono anche di natura tecnico-logistica: le basi a Malta sono quelle che sono, la pista di Luqa dove sono dislocati i Wellington è comunque corta per operare in sicurezza a pieno carico.

La prima missione è del 31 ottobre, obiettivo Napoli. La notte tra il 3 e il 4 novembre due Wellington non riescono a decollare e finiscono distrutti poco oltre la pista[1]. Il primo, matricola T2743[2], non riesce a prendere quota e precipita sulle case di Qormi, a poco meno di un chilometro dalla pista. Unica vittima il secondo pilota. Più tragico il destino del R1094 decollato quaranta minuti dopo e precipitato con la stessa dinamica colpendo però un’abitazione civile. Muoiono quattro dei cinque membri dell’equipaggio e i due coniugi che abitavano nella casa colpita, fortunosamente i loro figli si salvarono.
Nonostante le difficoltà iniziali e la necessità di non operare al limite del carico, fin da subito le missioni diventano incessanti, a ciclo continuo, rifornendo i velivoli e ruotando gli equipaggi. La guerra che combatte il Bomber Command della RAF a Malta non è la stessa guerra che combatte dai cieli dell’Inghilterra contro le città tedesche e italiane. Non si tratta di bloccare la macchina bellica con azioni contro le industrie e le città che le ospitano. Quella che si combatte a Malta è la lotta dei convogli per il predominio nel Mediterraneo.

Obbiettivo: il porto di Napoli
E non per nulla le prime azioni rilevanti che partono da Malta contro Napoli sono quelle contro le navi della Regia Marina nel porto della città campana. La prima azione di un certo peso è quella del 14 dicembre 1940 con due ondate di quattro bimotori Wellington del citato 148° Squadron con obiettivo il porto alla ricerca delle navi della Regia Marina rifugiatesi dopo lo smacco di Taranto del novembre precedente.
Seguirà un’altra azione contro le navi della Regia Marina l’8 gennaio 1941. Il porto, così come le aree industriali sono a ridosso dell’abitato, e sarà questo la principale causa dell’elevato numero di vittime civili.
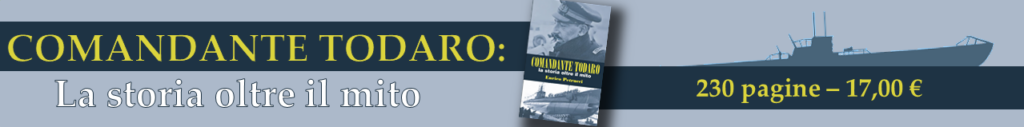
Pure come ricordano gli stessi Gioannini e Massobrio all’inizio le missioni da Malta sono inizialmente frequenti ma tutto sommato “modeste” «Per quanto frequenti, tuttavia, le incursioni da Malta saranno quasi sempre di modesta entità, condotte con pochi aerei e un proporzionale carico di bombe»[3].
Così come a gennaio 1941 si fermano le azioni contro il nord Italia, anche le azioni da Malta hanno subiscono uno stop progressivo all’inizio del 1941. Se la RAF cessa le azioni contro Genova, Torino e Milano per ottimizzare le risorse nelle missioni contro la Germania, il fermo delle azioni da Malta è legato alla pressione tedesca che si affianca a quella italiana contro la piazzaforte britannica nel Mediterraneo[4].
La “pausa” della prima metà del 1941
L’ultimo bombardamento su Napoli di questa fase è del 27 gennaio 1941, mentre a febbraio i Wellington del 148° Squadron sono ancora utilizzati contro obiettivi in Sicilia per tamponare l’offensiva tedesco-italiana in Africa settentrionale e la presenza della Luftwaffe in Sicilia, e alla fine a marzo i bombardieri maltesi saranno evacuati in Egitto[5].
Quando il X Fliegerkorps viene trasferito in Russia per l’Operazione Barbarossa del maggio 1941 le azioni contro Malta tornano a ricadere sulla sola Regia Aeronautica, e la Royal Air Force può tornare ad operare dall’isola mediterranea con relativa tranquillità.
I Wellington possono rientrare dall’Egitto a giugno e si aggiungono i bombardieri leggeri bimotore Bristol Blehnheim[6] E ricomincia la guerra contro i porti italiani per il predominio nel Mediterraneo. I bombardieri britannici tornano su Napoli il 9 luglio, la pausa è stata più breve di quella sulle città del nord Italia.
Riprendono le azioni da Malta contro Napoli
In questa rinnovata fase dele azioni su Malta aumenta la frequenza e l’intensità degli attacchi contro il capoluogo campano. Anche quattro notti consecutive e iniziano essere disponibili anche le prime blockbuster da 4.000 libbre utilizzate in Italia per la prima volta proprio contro Napoli la notte del 16 ottobre[7].
Se nel periodo del 1941-1942 si contano solo tre attacchi del Bomber Command partiti dall’Inghilterra con obiettivo l’Italia settentrionale, sul meridione si contano decine di azioni. L’obiettivo più colpito è la zona dell’aeroporto di Fontanarossa a Catania con trenta attacchi, ma è di fatto una zona isolata rispetto alla città capoluogo. Ben diverse le situazioni di Napoli con 24 attacchi e Palermo con 14[8].

Nell’articolo precedente scrivevamo che dal punto di vista dell’operatività del Bomber Command a essere determinante nel cambio dottrinale del febbraio 1942, ma dalla prospettiva dei cieli dell’Italia settentrionale il cambio di passo si realizza solo nell’ottobre 1942, quando in concomitanza con la nuova offensiva alleata (23 ottobre) che porterà all’ultima battaglia di El Alamein, inizia la nuova campagna di bombardamenti contro il nord Italia (notte del 22-23 ottobre su Genova)[9].
Arrivano gli Americani (e la Libia… e l’Algeria)
Anche per le azioni contro Napoli il cambio di passo è alla fine del 1942. In questo caso è l’entrata nello scacchiere italiano dei bombardieri statunitensi dell’USAAF. La prima azione su suolo italiano è quella di venerdì 4 dicembre 1942 con i Consolidated B-24 Liberator effettuano un’azione nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto. È il primo bombardamento diurno su Napoli. Gli aerei decollano dall’Egitto e non dalla Libia, anche se la Cirenaica è comunque fondamentale. Il campo di volo di Gambut sito a est di Tobruk, a metà strada la città e il confine con l’Egitto era stato riconquistato dalla 4th Infantry Brigade neozelandese il 25 novembre 1941 e viene utilizzato fin da subito per il rifornimento dei velivoli statunitensi ancora stanziati in Egitto. La tratta tra Gambut e Napoli è comunque di oltre 1.300 km.

I B-24 del 98° e del 376° Bombardament Group che colpiscono Napoli sono inquadrati nella 9th Air Force, l’Eastern Command, il comando orientale basato in Egitto. Dei 26 partiti solo 16 arrivano sul Napoli. Obiettivo sempre le navi in rada, e inevitabilmente il centro storico, affondato l’incrociatore leggero Muzio Attendolo, 188 vittime, danneggiato in maniera grave il pariclasse Montecuccoli, e in misura minore l’Eugenio di Savoia. 250 vittime complessive nel personale della Regia Marina.

Le vittime civili e militari del 4 dicembre 1942
A essere colpito anche il centro città: le bombe cadono sul Palazzo delle Regie Poste inaugurato nel 1936 e sui tram che transitano per l’adiacente via Monteoliveto, causando 47 morti[10].
E le vittime civili? Gioannini e Massobrio scrivono 159 vittime ufficiali segnalate dalle autorità all’epoca, precisando che il numero è probabilmente sottostimato. Nel podcast si parla di 900 vittime complessive. La cifra ripresa anche da Wikipedia e da lì ripresa da molta letteratura fa riferimento a un sito on-line dal 2006 Around Naples Encyclopedia di Jeff Matthews, californiano e napoletano d’adozione, professore di letteratura inglese all’Orientale di Napoli e al College dell’University of Maryland di Napoli dedicato al personale militare. L’origine dei 900 morti sarebbe I cento bombardamenti di Napoli, Aldo Stefanile, 1968. Mentre gli elenchi coevi della prefettura individuano 286 vittime e 667 feriti, cifra che si ritrova in altre pubblicazioni.
Questa variabilità di numeri perché sui bombardamenti di Napoli, a differenza delle tragiche vicende di più celebri bombardamenti come Dresda e Foggia, i numeri e le dinamiche non sono mai state oggetto di un’attenta revisione storiografica.
Qual è la peggiore azione di bombardamento contro Napoli?
Elemento evidente nel caso del bombardamento di Napoli del 4 agosto 1943 (che esula dagli argomenti del podcast che esamina la fase pre-25 luglio), che in molta letteratura divulgativa è presentato come l’azione più numerosa contro Napoli, con 400 B-17, un numero paragonabile alle azioni da centinaia di bombardieri contro l’Italia settentrionale o quella subita da Roma il 19 luglio.
In realtà l’azione più massiccia che subisce Napoli è quella del 17 luglio 1943[11] in cui a un’ottantina di quadrimotori B-24 del 9th Air Force, l’Eastern Command, si aggiungono più di 200 velivoli tra B-17 e B-25 del 321st Bombardament Group[12] del Northwest African Strategic Air Force, con basi dall’Algeria, ottenute dopo l’Operazione Torch del novembre 1942.
Le azioni più massicce di questa fase del conflitto, incluso l’operazione Crosspoint, ovvero il bombardamento di Roma del 19 luglio, sono possibili non per la disponibilità di campi di volo in Cirenaica o Tripolitania, ma per gli aeroporti in Algeria e Tunisia che consentono rotte chiaramente più brevi. Dai 1.300 km verso Napoli del primo bombardamento con pit-stop in Cirenaica del dicembre 1942, si scende a meno di 900 km per le basi di Algeria e Tunisia, e da cui possono operare anche i Wellington della RAF[13].
Roma il 19 luglio è colpita da quattro ondate per 523 bombardieri complessivi: quadrimotori B-17 e B-24, bimotori B-25 e B-26 decollati tra Algeria e Tunisia, a cui aggiungere 167 caccia pesanti bimotori di scorta P-38[14].
Il bombardamento di Napoli del 4 agosto 1943
Il bombardamento di Napoli del 4 agosto 1943 che nella memoria collettiva vede 400 B-17 in realtà è di “soli” 80 B-17[15] del 2nd Bombardament Group e del 301st Bombardament Group, sempre del Northwest African Strategic Air Force, il comando nord occidentale. Le vittime ufficiali all’epoca sono 210, ma Gioannini e Massobrio ipotizzano un numero tre volte superiore. Obiettivo formale le infrastrutture per i sommergibili[16] nel porto di Napoli, ma, al solito, le bombe cadono anche nel centro cittadino quasi distruggendo la basilica di Santa Chiara. E per la popolazione napoletana l’azione del 4 agosto diventerà quella più tragica nella memoria collettiva.

Leggenda di guerra
A proposito di immaginario collettivo il già citato Matthews, nel raccontare il livello di legendarium intorno alla tragedia dei bombardamenti di Napoli riporta in maniera caustica un passaggio del volume Breve Storia della città di Napoli di Giuseppe Campolieti, Mondadori Editore, 2004. Volume del 2004 per un editore di primissimo piano quindi. A pagina 251 si legge: «Si raccontò che, in quel periodo, bombardare NApoli e altre città italiane era diventato per i piloti americani una specie di sporto molto eccitante. Al punto che le gentili signore di quei piloti accompagnavano in volo i mariti, per provare così il bribido dell’atroce diversivo. Leggenda di guerra?»
Ecco, se si voleva dare conto di una “leggenda di guerra” forse c’erano modi più equilibrati per raccontarlo.
In conclusione
L’elemento da notare nei confronti dei bombardamenti alleati su Napoli è che quindi la disponibilità della piazzaforte maltese fu sfruttata fin da subito dalla Royal Air Force, nonostante i rischi corsi dai propri equipaggi nella prima fase delle operazioni nel novembre 1942.
La Royal Air Force non opera da Malta solo per quel breve periodo in cui la pressione italo-tedesca in Africa settentrionale con l’arrivo dell’Afrika Korps fece temere ai britannici per i destini della piazzaforte mediterranea.
E le azioni offensive da Malta testimoniano un altro aspetto dell’errore strategico italo-tedesco nei confronti dell’isola. Non era solo un elemento centrale della lotta per i convogli, ma una pericolosa postazione offensiva nei confronti dei porti e aeroporti del meridione italiano.
Infine il ruolo della Libia come punto di partenza per i bombardamenti alleati è quasi secondaria. Per ovvi motivi di distanza dagli obiettivi italiani e per una catena logistica che evitava per il periplo dell’Africa quelli che fecero la differenza furono gli aeroporti di Algeria e Tunisia.
Seguirà una terza puntata sullo spinoso tema del “radar” e sulla loro disponibilità sul territorio italiano.
Note
[1] Marco Gioannini, Giulio Massobrio, Bombardate l’Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945, Rizzoli, 2007, p.142-143
[2] Charles Debono, Remembering two bomber crashes at Qormi 80 years ago, Times of Malta, 3 novembre 2020
[3] p. 23
[4] p. 148
[5] p. 149
[6] p. 150
[7] p. 151
[8] p. 187
[9] p. 9
[10] p. 269
[11] p. 317
[12] 12th Air Force, 57th Bombardment Wing 321st Bombardment Group History: July 1943, p.177
[13] p. 270
[14] p. 335
[15] p. 344
[16] 12th Air Force, 57th Bombardment Wing 321st Bombardment Group History: August 1943, p.13