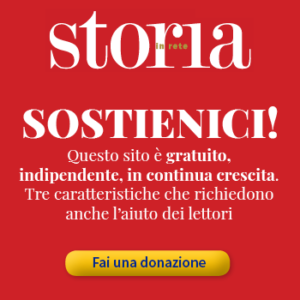Dal 24 aprile è disponibile sul sito de Il Post e su altre piattaforme il podcast Una mattina firmato da Luca Misculin e dedicato al racconto della Resistenza italiana a partire dal 1943. Un podcast che, come scrive nel catenaccio della pagina, «cerca di raccontare per bene la Resistenza». D’altronde, e con ragione, Il Post si fa vanto tra i giornali italiani di essere quello più attento alla qualità dell’informazione e allo scrupolo nel racconto delle notizie. Lo stesso scrivente in qualche occasione quando ha trovato quisquilie storiche imprecise le ha segnalate e la redazione le ha prontamente corrette.
Pure nel racconto del nuovo podcast, nonostante i riferimenti, la passione e l’attenzione al dettaglio, in merito ai bombardamenti sull’Italia dall’autunno 1942 alla prima parte del 1943 la narrazione è stata imprecisa. E pur non essendo l’argomento principale del podcast quello che trasmette è una certa confusione di fondo.
Si fa riferimento al passaggio tra il minuto 20 e il minuto 23 della prima puntata che riportiamo per completezza, evidenziando i passaggi più critici.
Il passaggio del podcast
«I bombardamenti degli aerei alleati sull’Italia sono ormai la normalità. Dopo che nel 1942 gli inglesi avevano sottratto il controllo della Libia all’esercito fascista i bombardieri partono da lì dalla Libia, oppure da Malta e sganciano tonnellate di esplosivo sulla città italiana e poi tornano. Nelle proprie basi l’Italia era già stata bombardata dagli austriaci durante la Prima guerra mondiale, ma stavolta gli attacchi sono molto più frequenti e soprattutto molto più mortali. Dato che ora gli aerei da guerra sono in grado di trasportare bombe che pesano ciascuna diverse tonnellate, gli alleati ne sganciano a migliaia sull’Italia perché la considerano l’anello debole dell’asse (l’alleanza fra Germania, Italia e Giappone) sia dal punto di vista geografico sia da quello politico e militare. Già negli anni Trenta, in realtà il regime fascista aveva installato sirene antiaeree in tutte le principali città, tenendo bombardamenti su larga scala. Le sirene sono collegate a un sistema di radar e proiettori di luce, che però riescono a individuare gli eremi nemici con un preavviso di pochi minuti. A volte neanche quello. A Roma di sirene ce ne sono ufficialmente 54 ed emettono sei suoni di 15 secondi con pause di uguale durata. Vengono attivate da due centrali operative.
Una si trova nei sotterranei del Ministero dell’Interno nel palazzo del Viminale. L’altra nella prefettura: sono le cosiddette stanze delle sirene.
Per molti nel 1943 quello delle sirene è l’ultimo suono che sentono prima di essere uccisi. La prima grande città italiana colpita da un bombardamento alleato nella nuova fase della guerra successiva alle pesanti sconfitte militari e Genova fra il 22 e il 23 ottobre 1942 bombardieri inglese con nomi come Lancaster, Stirling e Halifax sganciano sulla città 400 tonnellate di bombe, soprattutto nella zona del Porto. Il primo giorno muoiono 40 persone, il secondo diverse centinaia tra cui 354 nella cosiddetta galleria delle Grazie, un vecchio tunnel delle ferrovie che era stato riadattato a rifugio antiaereo. La galleria non viene colpita direttamente, ma decine di persone muoiono nella calca formata dalle centinaia di persone che si precipitano giù sotto terra per i 150 scalini della galleria. Dopo Genova tocca a Milano, poi Torino e Reggio Calabria. Ma i bombardamenti di gran lunga peggiori li subisce Napoli, probabilmente per via dell’importanza del suo porto per il regime fascista.
Il 4 dicembre del 1942 alle quattro del pomeriggio, una pattuglia di venti bombardieri statunitensi modello Liberator uccide in un solo attacco su Napoli 900 persone dei primi giorni del 1943 in città. I bombardamenti diventano addirittura quotidiani e soltanto a Napoli soltanto nel 1943 le bombe alleate uccidono più di 6.000 persone»
Riassumendo da questo passaggio si evincerebbe:
- I bombardamenti dell’autunno 1942 sono possibili grazie alla conquista della Libia, e in seconda misura da Malta.
- Il ruolo di Napoli come obiettivo principale delle campagne di bombardamento alleate. Indubbio dal punto di vista delle vittime, ma da contestualizzare sul piano operativo di “bombardamento peggiore”.
- Il fatto che l’Italia disponesse di Radar antiaerei integrati con la difesa aerea cittadina alle dipendenze del DICAT.
Facendo riferimento al fondamentale e insuperato Bombardate l’Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945, Rizzoli, 2007, (poi ristampato per Mondadori nel 2021 come L’Italia bombardata: Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945) di Gioannini e Massobrio sia al lavoro svolto per lo speciale di Storia in Rete Bombe sull’Italia del luglio 2019 (qui disponibile in ebook) andiamo a ricostruire il contesto della guerra aerea sopra l’Italia.

Un’Italia divisa in due per il Bomber Command
L’Italia fin dall’inizio della guerra dal punto di vista del Bomber Command della RAF è di fatto divisa in due.
- L’Italia nord-occidentale è sempre stata raggiungibile dalle operazioni di bombardamento dall’Inghilterra della RAF, che a partire dall’autunno 1942 diventeranno operazioni di area bombing su vasta scala;
- L’Italia meridionale è nel raggio d’azione per le operazioni da Malta dei britannici, che per il minor numero di velivoli disponibili nella piazzaforte britannica e per la minore disponibilità di piste, saranno quasi sempre operazioni teoricamente contro obiettivi mirati come il porto, l’aeroporto e le aree industriali. Ma la frequenza e la costanza dei bombardamenti, assieme alla densità e la posizione della città, renderanno Napoli la città italiana con il maggior numero di vittime da bombardamento, con un numero di morti dieci volte superiore a quello delle città industriali del centro e nord Italia.
- Il ruolo della Libia come base di partenza rimane però secondario nel quadro generale delle operazioni, anche se consentirà nella fase iniziale (prima dell’occupazione della Sicilia), le prime azioni di bombardamento statunitensi da parte dell’USAAF, come il primo bombardamento diurno di Napoli nel dicembre 1942 citato nel podcast (Per semplificare la RAF opera di notte, l’USAAF di giorno). Operazioni che però partirà dall’Egitto e in cui la Libia servirà per un pit stop.
- In realtà il cambio di passo per le operazioni alleate dal Nord Africa non sarà tanto la Libia, ma la possibilità di operare dall’Algeria prima e dalla Tunisia poi grazie all’operazione Torch. Il bombardamento di Roma del 19 luglio 1943 sarà realizzato con due ondate decollate proprio da Algeria e Tunisia.
- E sui radar? Beh, qualche radar tedesco c’era, ma non c’era un vero “collegamento” con le sirene antiaeree.
In questa prima parte ci limiteremo all’esame della situazione dei bombardamenti alleati sull’Italia nord occidentale e del perché nell’autunno 1942 si inneschi un radicale cambio di passo.

I bombardamenti dall’Inghilterra
Come detto gli obiettivi sull’Italia nord occidentale erano già raggiungibili dalle basi dall’Inghilterra fin dall’entrata in guerra dell’Italia nel giugno 1940 con velivoli non a pieno carico di bombe. Altri obiettivi quali Nord Est e l’Italia centrale, in particolare Livorno, sono al limite operativo dei velivoli allora disponibili, principalmente i bimotori Armstrong Whitworth Whitley e Vickers Wellington[1].
Ma ci sono altri due fattori da considerare per queste operazioni. Innanzitutto il sorvolo delle Alpi, e la necessità di svolgere l’intera missione in notturna, specialmente per non rischiare durante il sorvolo della Francia. Quindi dopo qualche operazione tra il 1940 e l’inizio del 1941 il Bomber Command della RAF riterrà opportuno concentrare i suoi sforzi sulla più raggiungibile Germania.

La prima operazione del Bomber Command della RAF dall’Inghilterra contro Torino e Milano effettuata dopo l’armistizio dalla Francia e il ritiro della RAF dal suolo francese (e dalle isole del Canale) è nella notte del 13 agosto 1940 in cui vengono colpite Milano e Torino con 35 bimotori Armstrong Whitley. Azione che rimane la più massiccia di questa fase iniziale e che al netto delle vittime rimangono principalmente azioni simboliche. Comunque tra agosto 1940 e gennaio 1941 si contano 10 azioni su Torino, 6 su Milano, con un’incursione che arriva fino a Porto Marghera[2].
Le azioni del Bomber Command contro Genova, Torino e Milano, si fermeranno quasi del tutto per il resto del 1941 fino all’autunno del 1942. Gioannini e Massobrio riferiscono di soli 3 attacchi in questa fase successiva[3].
Bombardamenti dall’Inghilterra: nel febbraio 1942 cambia tutto
L’elemento dirimente delle azioni su Genova, Milano e Torino rimane però principalmente tecnico e in seconda misura teorico-organizzativo. Tutti fattori che cambieranno radicalmente nel febbraio 1942. Non appena iniziano a essere disponibili bombardieri migliori e più capaci come il quadrimotore Avro Lancaster entrato in servizio nel febbraio 1942, che si affianca agli altri quadrimotori Stirling e Halifax già disponibili le tre città italiane diventano obiettivi ragionevoli nell’economia del Bomber Command e a cui dare maggiore priorità vista la natura dell’anello debole dell’Italia.
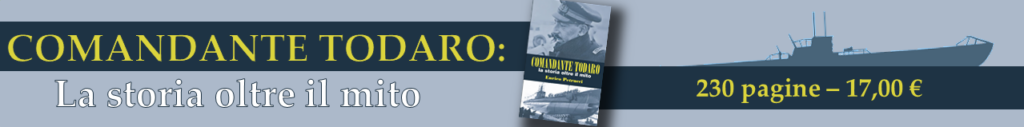
Sempre nel febbraio 1942 a comandare il Bomber Command della RAF arriva Sir Arthur Harris, “affettuosamente” soprannominato dai suoi uomini butcher, il “macellaio”, per l’indifferenza verso le perdite dei suoi stessi equipaggi.
C’è l’elemento tecnico, il Lancaster, c’è l’elemento organizzativo, Arthur Harris al comando. E c’è l’elemento teorico, l’Area Bombing Directive emanata il 14 febbraio 1942, su indicazione del primo consigliere scientifico del governo Churchill, Frederick Lindemann. Direttiva dedicata alle grande aree industriali della Germania che mira esplicitamente a demoralizzare la popolazione e i lavoratori. E a cui seguirà, nel marzo successivo, sempre su indicazione di Lindemann il memorandum sul dehousing, ovvero lo “sloggiamento” della popolazione per distruzione da bombardamento delle abitazioni.
Dal punto di vista dottrinale non sono più solo le zone industriali l’obiettivo, ma l’intera area urbana.
Centinaia di velivoli
Basta vedere i numeri delle azioni contro Genova e Torino dell’ottobre-dicembre 1942 per comprendere il cambio di passo del Bomber Command della RAF, e tutto questo con operazioni che come detto muovono dal suolo britannico[4].
- Genova: 22 ottobre, 112 velivoli; 23 ottobre,122 velivoli; 7 novembre, 175 velivoli; 13 novembre, 76 velivoli; 15 novembre, 78, velivoli;
- Torino: 18 novembre, 77 velivoli; 20 novembre, 232 velivoli; 28 novembre, 228 velivoli; 8 dicembre, 133 velivoli; 9 dicembre, 227 velivoli; 10 dicembre, 82 velivoli.
Da segnalare nello stesso periodo il bombardamento su Milano del 24 ottobre con 162 velivoli.
Insomma nei confronti delle azioni contro Genova e Torino di fine 1942 l’Africa settentrionale non c’entra. Le città del nord ovest videro massicce azioni della Royal Air Force con centinaia di velivoli partiti dall’Inghilterra.
E la più grossa azione in termini quantitativi contro una città italiana è proprio quella contro Milano della notte del 12 agosto 1943, con 504 bombardieri: 321 Avro Lancaster e 183 Handley Page Halifax. Numeri comparabili con quelli delle azioni contro le città tedesche, pur senza arrivare ai record delle tre occasioni in cui la RAF impiegò i 1.000 bombardieri contro Colonia, Essen e Brema tra il maggio e il giugno 1942.

Nonostante i numeri di bombardieri dispiegati nelle missioni di bombardamento contro le città settentrionali le vittime civili furono comunque inferiori a quelli di Napoli. Circa 2.500 vittime Bologna, 2.200 Milano, 2.000 per Torino e Genova.
A Napoli si contano invece tra le 20.000 e le 25.000 vittime. A fare la differenza come anticipato, la frequenza e la costanza dei bombardamenti, più che la violenza delle singole azioni, come vedremo nel prossimo articolo.
[1] Marco Gioannini, Giulio Massobrio, Bombardate l’Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945, Rizzoli, 2007, p. 99
[2] Ivi, p. 98
[3] Ivi, p. 186
[4] Per i dati si è fatto riferimento al database The Bombing War in Europe 1943 1945 Created creato dall’University of Lincoln e dall’International Bomber Command Centre