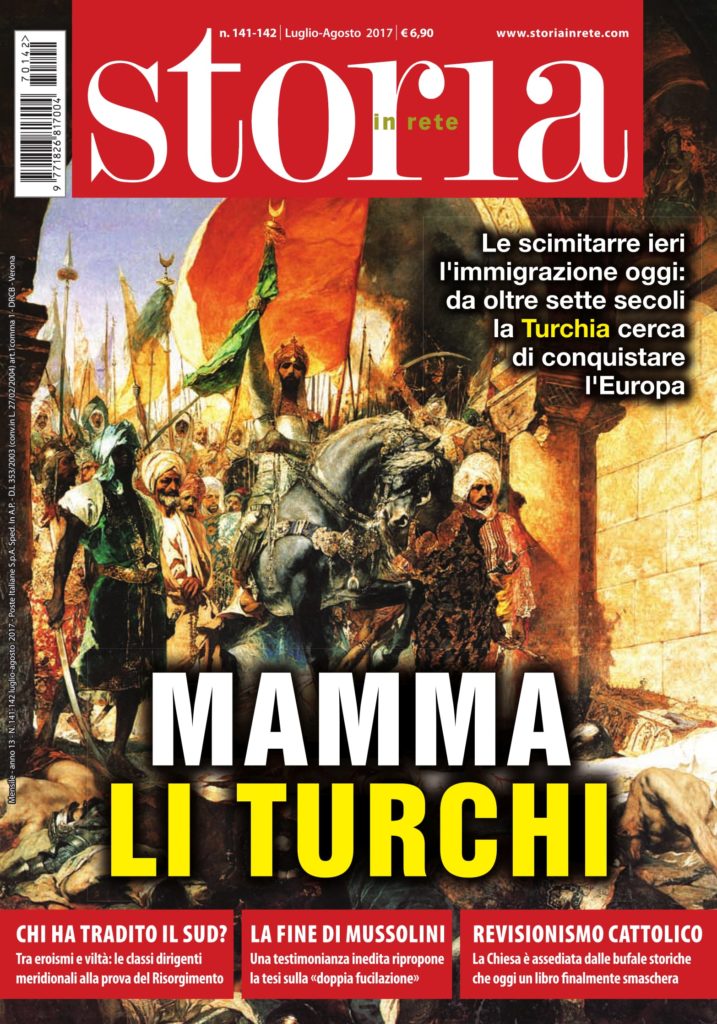di Fabio Figara per Storia in Rete del 25 febbraio 2025
Una folta barba incornicia il volto magro di un uomo dal portamento regale. I suoi occhi non nascondono la maturità e il peso delle preoccupazioni. Una corona d’oro poggia sul suo capo, e folti capelli mossi scendono verso le spalle. È un affresco scoperto durante i lavori di manutenzione all’interno della chiesa del monastero di Taxiarchon, luogo di culto ultracentenario situato a circa 15 chilometri dalla città di Aigio, nel Peloponneso. Analizzando lo stile artistico dell’opera, ritrovata in un secondo strato di pitture murali, Anastasia Koumousi, direttrice dell’Eforato delle Antichità dell’Acaia, e il gruppo di archeologi facente parte del progetto di restauro, hanno potuto datarla al XV secolo.
Ma non solo: secondo quanto dichiarato dalla stessa Koumousi, il personaggio raffigurato potrebbe essere Costantino XI Dragazes Paleologo (Dragazes era la forma greca del nome serbo della madre, Elena Dragaš), l’ultimo imperatore dei romani d’Oriente, morto in battaglia durante l’assedio portato a Costantinopoli dalle truppe del sultano ottomano Mehmed (o Mehmet, Maometto) II che portò alla capitolazione definitiva della città. La notizia, subito riportata anche dal ministro della Cultura greco Lina Mendoni, ha indubbiamente suscitato grande emozione nella comunità accademica, considerando che non si conoscono ritratti ufficiali contemporanei all’esistenza in vita di Costantino XI, e che la rappresentazione artistica, contrariamente ai criteri dell’epoca – che prediligevano dettagli maggiormente stilizzati per le figure di rango elevato – presenterebbe invece l’Imperatore come nella realtà.
In attesa di altri studi e approfondimenti, la certezza è di trovarsi di fronte ad un’opera unica nel suo genere per il periodo a cui appartiene. La figura rappresentata ha attributi che effettivamente rimandano ad un imperatore bizantino: il mantello di porpora e d’oro che lo ricopre; le aquile bicipiti con corone che vi spiccano (segno distintivo dei Paleologi al potere) all’interno di grandi medaglioni; lo scettro con croce ad un’estremità, impugnato con la mano destra. Il nesso con Costantino sarebbe comunque da ricollegarsi alla storia dello stesso Monastero di Taxiarchon e alle vicende della famiglia dei Paleologi. I fratelli di Costantino, ovvero Demetrio e Tommaso Paleologo, finanziarono generosamente la ristrutturazione del monastero dopo la fine degli scontri tra loro. Si suppone la provenienza dell’artista da Mistrà, città dove Costantino visse come despota per cinque anni prima di ascendere al trono di Costantinopoli.
Tale scoperta, in attesa di evidenti approfondimenti, è importante anche perché riporta alla luce il ricordo dell’ultimo Imperatore bizantino, venerato come santo e martire presso le Chiese orientali, e della difesa di Costantinopoli durante l’assedio turco del 1453, che gli costò la vita e vide la capitolazione definitiva dell’Impero bizantino.
La potenza ottomana aveva conosciuto una sorta di rinascita con il nuovo e giovane Sultano (aveva appena diciannove anni): questi, piuttosto bellicoso e intenzionato a risolvere il problema di Bisanzio, inizialmente si mostrò amichevole nei confronti di Costantino. Purtroppo le speranze di un pacifico e duraturo rapporto tra le due potenze vennero subito meno. Per lui una città come Costantinopoli ancora cristiana poteva rappresentare una costante minaccia agli interessi del suo impero.
Nell’aprile del 1451 Mehmed iniziò la costruzione di una fortezza sul litorale europeo, Rumeli Hissar – completata in appena dodici settimane – chiudendo e controllando così il Bosforo. Il motivo della manovra di Mehmed era ormai evidente. Costantino aveva assolutamente necessità di un aiuto militare da parte delle potenze occidentali. E l’unico modo per tentare di ottenerlo era di riunificare le due Chiese latina e greca.
L’anno successivo, in Santa Sofia, fece così officiare una Santa Messa con rito romano dal cardinale Isidoro di Kiev (giunto con un paio di centinaia di soldati), e annunciandone ufficialmente l’unione attraverso la lettura del decreto d’unione firmato nel corso del Concilio di Firenze del 6 luglio 1439.
Di fatto questo era un problema che aveva già cercato di risolvere l’Imperatore precedente, Giovanni VIII Paleologo, proprio in un tentativo di attirare a sé, in caso di necessità, le attenzioni del Papa e delle principali potenze europee. L’Impero bizantino era infatti ridotto ad un piccolo Stato comprendente la stessa capitale e pochi altri territori, e che soffriva dell’espansionismo turco già da tempo. E la stessa Costantinopoli, nel giro di circa 30 anni, aveva visto ridurre la propria popolazione a causa di assedi ed epidemie, i commerci erano ormai completamente in mano ai mercanti veneziani e genovesi, e la moneta si era più volte svalutata, con introiti diretti sempre più limitati per le casse statali.
Nel tentativo di tessere un’importante rete diplomatica, Giovanni riuscì comunque a far sancire tale unione proprio a Firenze. Tuttavia fu una scelta che, sul piano interno, creò non pochi problemi all’Imperatore: al suo rientro si scontrò purtroppo con importanti opposizioni in seno alla Chiesa greca (molti firmatari ritrattarono e si allontanarono dalla corte bizantina, tra cui il principe di Mosca Basilio II), e si attirò il disprezzo di molti suoi sudditi. La Chiesa ortodossa era lacerata, e anche il patriarca Gregorio III, che aveva appoggiato l’unione, era ormai odiato dal proprio gregge.
Nel frattempo era anche fallita miseramente un’ennesima crociata delle potenze europee per liberare i Balcani dai Turchi (1444), con una pesante sconfitta subita nei pressi di Varna, nell’attuale Bulgaria. Due anni dopo, i Turchi attaccheranno e devasteranno la Morea: l’Examilion, il muro che chiudeva l’istmo di Corinto, venne sfondato senza problemi. Nel 1448, deluso e amareggiato, ad appena 55 anni, Giovanni morì nella capitale.
Anche la scelta di Costantino, che ereditò questa pesante situazione da Giovanni, di sancire definitivamente l’unione delle due Chiese, alla fine si rivelò un fallimento: i fedeli disertarono cerimonie e festeggiamenti. Pur consci che il momento critico richiedeva unità, non vollero rinunciare alle proprie tradizioni e ai propri riti.
Nell’aprile del 1453 Mehmed iniziò l’attacco con oltre 150 mila uomini e cannoni di bronzo, costruiti e progettati da ingegneri occidentali. Le mura di Costantinopoli, restaurate come possibile sia da Giovanni che da Costantino, erano difese da molto meno di 10 mila uomini tra cui veneziani, catalani, genovesi e un gruppo di turchi alleati dei bizantini. Si sperava in aiuti dall’Europa, soprattutto da Venezia, soccorso che non arriverà mai. Forse la sconfitta di Varna era ancora fresca – soprattutto delle spese – forse fu sottovalutato il reale potere politico e militare di Mehmed o, ancora, probabilmente si considerava Costantinopoli già perduta: di fatto le navi in partenza furono fermate dal senato della città lagunare.
Dopo un assedio durato meno di due mesi, il 29 maggio Mehmed sferrò così l’attacco finale con tre ondate di assalitori: la prima di irregolari (bashi-bazuk) con numerose scale d’assedio, la seconda di regolari e la terza di giannizzeri, le truppe scelte del Sultano. Il basileus Costantino, dopo aver partecipato alla Messa in Santa Sofia (stavolta) con cattolici e ortodossi, resistette all’assedio insieme ai pochi uomini rimasti, morendo eroicamente nella mischia. Un cronista riportò che il corpo di Costantino venne riconosciuto dalle aquile imperiali ricamate sui calzari: sicuramente i suoi resti furono nascosti per non offrire possibilità di eventuali pellegrinaggi e commemorazioni. La capitale dell’Impero romano d’Oriente venne così espugnata e saccheggiata. Era la fine di un’era.