di Nigel Biggar da The Telegraph del 9 settembre 2025 – traduzione SiR
C’era un tempo in cui i più abbienti ostentavano il loro status acquistando ville, guidando auto di lusso e indossando cappelli a cilindro. Oggi si ritiene comunemente che il privilegio sia vergognoso. Le élite occidentali preferiscono ostentare uno status morale superiore sostenendo cause “progressiste” alla moda. Queste sono “credenze di lusso” perché non costano nulla alle élite, mentre costano molto ad altri. Una di queste cause è quella della “decolonizzazione”, che diffama i quattrocento anni di attività coloniale della Gran Bretagna come una semplice litania di razzismo, sfruttamento e oppressione, di cui la schiavitù è l’epitome.
Ora, tuttavia, la “decolonizzazione” rischia di diventare davvero molto costosa. Infatti, sfruttando l’orgia performativa di autoflagellazione dell’Occidente, l’Unione Africana si è appena unita alla Comunità Caraibica (“Caricom”) nel chiedere alla Gran Bretagna un risarcimento per i suoi “crimini coloniali”. La Caricom ha già presentato la sua richiesta di 18.000 miliardi di sterline. La richiesta del continente africano è destinata a essere ancora più elevata.
Ma la caricaturale storia della “decolonizzazione” dei rapaci coloni britannici che sfruttavano vittime africane indifese è una caricatura della verità storica. Prendiamo la questione della schiavitù. Gli africani avevano ridotto in schiavitù altri africani per secoli. Quelli che non consumavano in sacrifici umani venivano venduti prima ai Romani e poi agli Arabi. Pochi anni prima che la prima nave negriera britannica arrivasse sulle coste dell’Africa occidentale nel 1563, un testimone portoghese aveva riferito che il regno africano del Congo esportava tra i quattromila e gli ottomila schiavi all’anno.
Trecento anni dopo, gli arabi dell’Oman gestivano piantagioni di schiavi sulla costa dell’Africa orientale, e gli africani Fulani le gestivano nel Califfato di Sokoto, nell’attuale Nigeria settentrionale. Infatti, secondo lo storico Mohammed Bashir Salau, il Califfato divenne “una delle più grandi società schiaviste della storia moderna”, eguagliando gli Stati Uniti per numero di schiavi (quattro milioni).
Nel frattempo, gli inglesi si erano pentiti del loro coinvolgimento nella tratta degli schiavi e nella schiavitù, e all’inizio del XIX secolo furono tra i primi popoli nella storia del mondo ad abolirli. Poi, dopo la battaglia di Waterloo del 1815, sfruttarono il loro dominio globale per sopprimere sia il commercio che l’istituzione dal Pacifico nord-occidentale, attraverso l’Africa e l’India, fino alla Nuova Zelanda. A metà del secolo, la Royal Navy dedicò oltre il 13% della sua forza lavoro totale a fermare il traffico di schiavi tra l’Africa occidentale e il Brasile.
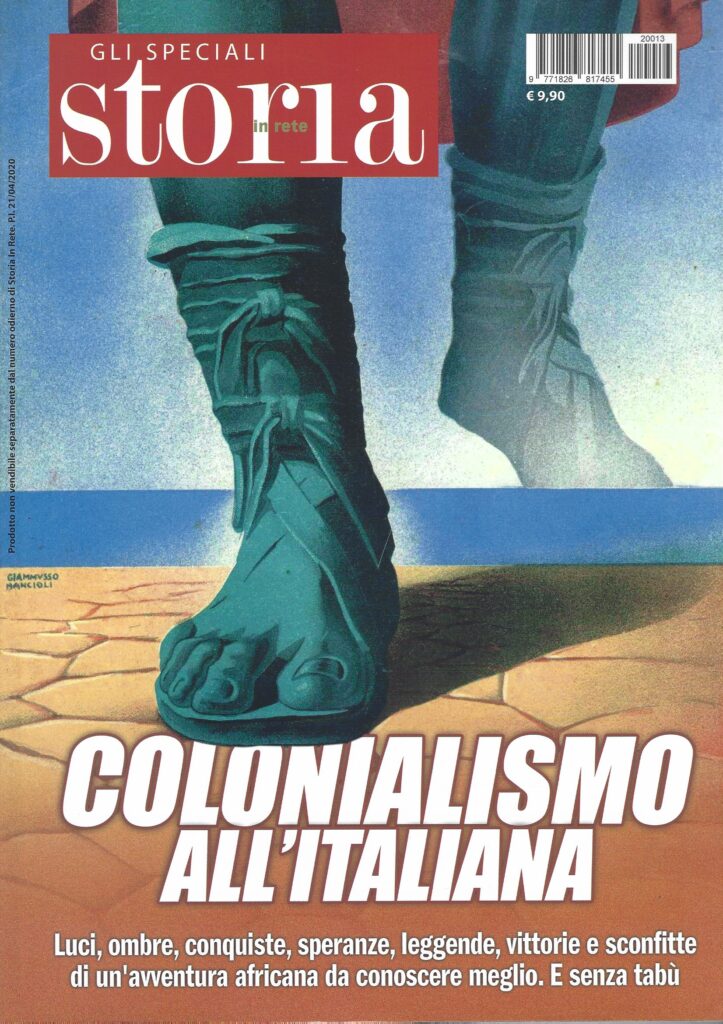
Allo stesso tempo, l’idea di Sir Thomas Fowell Buxton secondo cui la chiave per porre fine alla tratta degli schiavi e alla schiavitù in Africa fosse promuovere un commercio “legittimo” alternativo stava guadagnando terreno. Ciò portò alla creazione di avamposti commerciali nell’Africa occidentale e, in seguito, quando i mercanti si lamentarono della mancanza di sicurezza, a una presenza coloniale più decisa sulla terraferma.
Nel 1851, dopo aver tentato invano di convincere il suo sovrano a porre fine al commercio di schiavi, gli inglesi attaccarono Lagos e ne distrussero le strutture. Dieci anni dopo, quando nel 1861 si tentò di rilanciare il commercio, annetterono Lagos come colonia. Si osservi qui la logica evolutiva del “colonialismo”: prima l’intento umanitario; poi la promozione del commercio; e infine, l’imposizione del dominio coloniale.
Contrariamente a quanto sostiene Sir Hilary Beckles, paladino delle riparazioni della Caricom, i governanti africani si opposero generalmente agli sforzi britannici contro la schiavitù. Lo storico beninese Abiola Félix Iroko ha scritto che “quando la tratta degli schiavi fu abolita [dagli inglesi], gli africani erano contrari all’abolizione”. John Iliffe, professore di storia africana all’Università di Cambridge, concorda, scrivendo che “molti leader africani si opposero all’abolizione della tratta degli schiavi. I re di Ashanti, Dahomey e Lunda avvertirono tutti che i prigionieri invenduti e i criminali avrebbero dovuto essere giustiziati”.
A differenza della meschina esibizione di virtù “decolonizzatrice”, la sostenuta campagna britannica contro la schiavitù fu costosa sia in vite umane che in denaro. Millesettecento marinai morirono al servizio della Royal Navy per fermare la tratta degli schiavi via mare. Nel frattempo, sulla terraferma, i missionari cristiani rischiarono – e spesso persero – la vita nel tentativo di chiudere i mercati degli schiavi in Africa. Tra loro c’era il vescovo anglicano Charles Mackenzie, che morì orribilmente di febbre delle acque nere in quello che oggi è il Mozambico nel 1862 all’età di 37 anni.
David Eltis, descritto da Henry Louis Gates dell’Università di Harvard come “il principale studioso mondiale della tratta degli schiavi”, ritiene che la spesa per la soppressione della schiavitù nel XIX secolo abbia superato i benefici del XVIII secolo. E i politologi Chaim Kaufmann e Robert Pape hanno concluso che il solo sforzo della Gran Bretagna per reprimere la tratta atlantica degli schiavi nel periodo 1807-1867 sia stato “l’esempio più costoso [di costosa azione morale internazionale] registrato nella storia moderna”.
La richiesta di riparazioni coloniali da parte dell’Unione Africana è un atto di cinico opportunismo. Ma se le nostre élite non impareranno a preoccuparsi meno di ostentare la propria virtù e più di rendere giustizia alla storia del proprio Paese, ne pagheranno le conseguenze per tutti noi.
Lord Biggar è l’autore di Reparations: The Tyranny of Imaginary Guilt.


