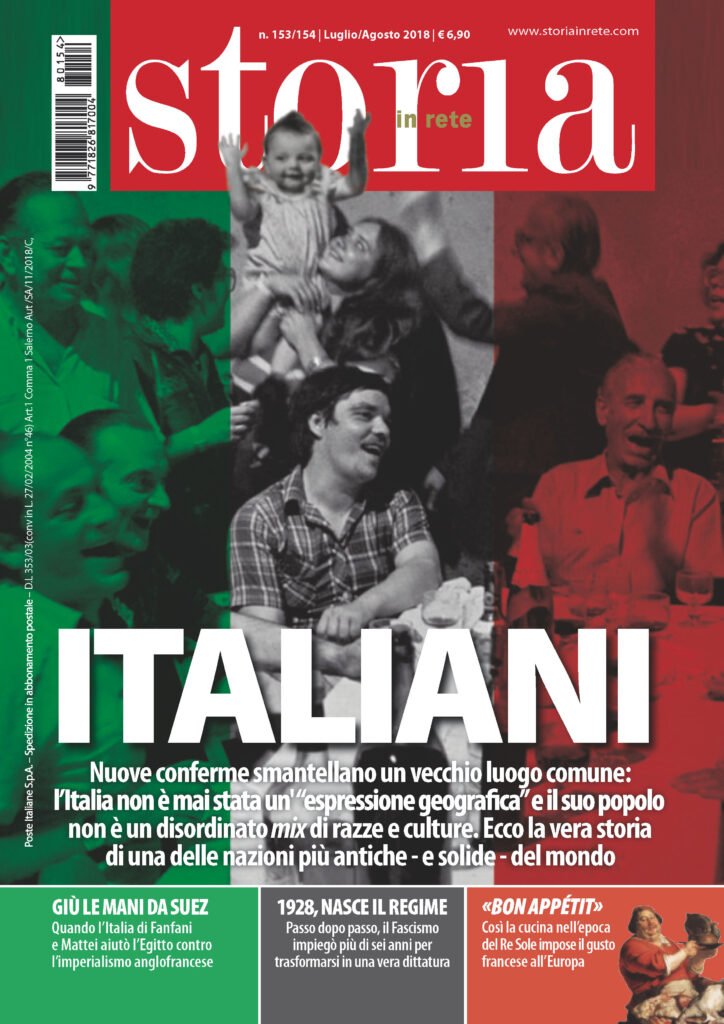Le affermazioni della candidata di “Toscana Rossa”, Antonella Bundu, circa la necessità di “smantellare la bianchezza” hanno scatenato una polemica feroce, alla quale la sua parte politica ha reagito more solito con la consueta geremiade sul “razzismo” nei confronti della Bundu, italo-ghanese con una biografia cosmopolita. Un’accusa lanciata in particolar modo contro la giornalista Francesca Totolo, fatta oggetto di un vero e proprio linciaggio sui media mainstream. La sottotraccia del discorso wokeista e decostruzionista sulla “bianchezza” – conio dall’inglese “whiteness” – è che i popoli bianchi devono rinunciare alla loro natura etno-razziale per far posto agli immigrati (o ai discendenti degli schiavi, come negli USA) e, in Europa e segnatamente nel caso della Bundu, accettare una nuova natura “meticcia”. Alla base di questa rinuncia, una colpevolizzazione dell’uomo bianco, un vero e proprio rovesciamento delle tesi d’epoca coloniale, come il celebre “fardello” di kiplinghiana memoria, il quale deve considerarsi un oppressore, colonialista (termine inteso in senso deteriore) e depositario di tutte quelle altre caratteristiche (patriarcato, bigottismo, eteronormatività etc.) che il wokeismo ritiene essere l’epitome del male.
Ma ha senso parlare di “meticciato” per le nazioni europee e in particolar modo per la nostra nazione italiana? Categoricamente no, soprattutto nel senso in cui viene invocato dai sostenitori dell’immigrazione di massa. Non tanto per motivi razionali, primo fra i quali è chiedere a quegli italiani meticci o ai “nuovi” italiani se il loro desiderio di poter far parte della storia trimillenaria della nostra nazione consista nel negarla e volerla cambiare radicalmente, geneticamente.
Piuttosto è la storia del fenomeno migratorio, della nascita delle nazioni in Europa, della fusione e delle assimilazioni reciproche fra i popoli d’età classica e altomedievale che ci mette di fronte al più secco niet per quanto riguarda l’immigrazione: l’Arte di Clio parla chiaro e ci racconta senza equivoci di una scia di sangue, oppressione, sostituzione etnica (e veri e propri genocidi) che prevede diversi “prima” e “dopo”, crinali oltre i quali pensare di ripetere le esperienze del passato è impossibile. Ma procediamo con ordine.
L’avvertimento di Raspail
La nuova edizione del celeberrimo e agghiacciante romanzo di Jean Raspail Il campo dei santi è innovativamente accompagnata da un saggio introduttivo estremamente interessante intitolato The Big Other. Il testo, sempre a firma di Raspail, analizza a partire dal gioco di parole orwelliano del titolo, l’ossessione per “l’altro” che permea la civiltà europea della seconda metà del XX secolo, identificandone l’essenza di cupio dissolvi oicofoba.
“Il vocabolo français de souche non ha alcun senso. Noi eravamo tutti meticci”, scrive Raspail citando un articolessa a cinque colonne da Le Figaro (dunque non esattamente L’Eco di Pavullo…) del 27 gennaio 2010. Uno dei suggelli alla campagna di annientamento ideale dei “francesi di stirpe” iniziata da decenni e e che dovrebbe coronarsi con il riconoscimento dell’essenza “meticcia” di quel popolo (e in ultima analisi di tutti i popoli europei).
Un’affermazione rozza ma d’effetto. Una “innovativa truffa semantica”, la bolla Raspail. Del resto i francesi sono la somma di Galli e Romani, Franchi, Burgundi e Alamanni, Normanni ed Ebrei, e poi gli immigrati del XIX e XX secolo da Italia, Polonia, Portogallo… Non è questo “meticciato”? Sì e no. “Era Europa invitata a casa propria” taglia corto Raspail.
Il problema, analizzato da una prospettiva storica e antropologica, può essere ulteriormente approfondito. E i risultati di un ragionamento storico darebbe risposte molto interessanti anche su chi e cosa siamo noi italiani. Un tema che il Centro Studi Machiavelli ha sviscerato in un dossier che verrà presentato nelle prossime settimane e che vale la pena di anticipare in parte qui.
La Storia è maestra ma non ha allievi…
Fra i sostenitori della tesi secondo cui saremmo tutti “meticci” è molto in voga citare l’Impero Romano come perfetto esempio di “meticciato”, di compagine multi-etnica, multi-religiosa e multi-razziale. Il che è vero: si trattava di un impero, ossia di una struttura statuale che al suo centro annetteva territori, popoli e nazioni periferiche in una realtà molteplice: in cui comunque c’era chi comandava (il ceppo romano-italico) e chi stava sotto (gli altri). I Romani tendevano comunque ad assorbire gli elementi più proattivi (oggi diremmo “collaborazionisti”) dei popoli sottomessi per romanizzarli e farli parte della propria aristocrazia di potere. Nel frattempo una porzione non irrilevante dei milioni di schiavi importati in Italia veniva regolarmente manomessa e acquistava per sé e soprattutto per i propri discendenti il privilegio della cittadinanza, non prima comunque d’aver assimilato ogni aspetto della vita degli ex padroni.
Dunque, tutto andava come dicono i corifei dell'”accoglienza” e del “meticciato”? Niente affatto. Perché intanto – parafrasando Raspail – nella stragrande maggioranza dei casi i “nuovi Romani” accolti nel seno dell’Impero erano “mediterranei in casa propria”. Salvo insignificanti porzioni di schiavi subsahariani, la stragrande maggioranza dei sudditi imperiali e degli schiavi proveniva dal bacino mediterraneo e aree viciniori: si trattava di popolazioni caucasiche, per lo più indoeuropee-nordiche o semitiche e camitiche (in minor parte), queste ultime già molto amalgamate fra loro dall’Ellenismo alessandrino. Dunque, tutti appartenenti alla medesima stirpe. Con la notevole eccezione dei Giudei, eccezione che conferma la regola, qualunque suddito o cittadino imperiale poteva spostarsi da un capo all’altro della Respublica e trovare un tempio in cui pregare il proprio Dio. Cosa che – nonostante tutti gli irenismi da Concilio Vaticano II – oggi nessuna persona può fare liberamente in qualunque Stato, perfino il più laico. L’epoca del monoteismo è radicalmente differente dal politeismo antico, in cui storici e viaggiatori si ingegnavano per capire semplicemente come gli altri popoli chiamassero Ammone, Ermes o Minerva…
Esisteva dunque un’unità nelle diversità che oggi è totalmente assente e non più realizzabile (spiace per John Lennon…). E questa è la prima delle differenze. La seconda, non meno importante, è che duemila anni fa non esistevano le nazioni come noi le abbiamo concepite nel corso del Medioevo e come si sono poi cristallizzate nell’Evo Moderno. L’Europa moderna è fatta di Stati-nazione, cosa che può piacere o non piacere (a noi piace), ma che non è aggirabile né ignorabile. La Storia è dunque una severa maestra.
Nasce, nel sangue, la nazione
Non che gli antichi non avessero il concetto di stirpe. Ma esso era più elastico, anche legato a tradizioni ancestrali in cui l’esogamia era un valore (prendere – in molti sensi – moglie fuori dal proprio clan significava stringere legami strategici, ridurre tensioni e rivalità all’interno del clan, introdurre geni nuovi in pool genetici spesso ristretti etc.). Nel crepuscolo di Roma giungono però a cambiare e innovare questi costumi nuove categorie. Le portano i Giudei, primo popolo del Mediterraneo a concepirsi come assolutamente estraneo ai suoi vicini e irriducibile, e i barbari germanici, in cui il concetto di sangue supera qualunque ipotesi di adesione volontaristica alla tribù da parte di esterni: si nasce Longobardi o Burgundi, non lo si diventa. Un concetto non dissimile da quello degli slavi (che si affacceranno in Europa occidentale un paio di secoli dopo).
Come queste nuove concezioni, ibridandosi fra loro, abbiano portato alla nascita delle moderne nazioni è molto lungo, complesso ed esula dagli scopi di questo breve articolo. Di fatto però alla fine dell’esperienza carolingia già i “volghi dispersi”, i tanti cocci dell’Impero Romano tramontato da sei secoli, stavano prendendo la forma delle moderne nazioni. Prima fra tutte l’Italia, favorita anche dalla sua peculiare geografia.
Anche qui, il tifoso del “meticciato” salterà su e avrà di che sostenere: “l’Italia non è forse nata con l’arrivo di immigrati Goti, Longobardi, Saraceni e altri? Siamo dunque meticci anche noi!”. Oltre a parafrasare anche qui la risposta di Raspail sull’analoga domanda posta per i francesi, si può concedere senza alcun problema che il popolo italiano sia nato anche grazie a questi contributi. Ma, per l’appunto, nasce.
E come tutti i parti avviene nel sangue e nel dolore. I popoli che migrano in Italia diventano presto tracotanti padroni: i Goti combattono coi Bizantini per il possesso della Penisola per decenni in un conflitto apocalittico. Il dominio gotico e poi quello longobardo in Italia non furono indolori: i nuovi dominatori si comportarono per l’appunto come tali, opprimendo e saccheggiando i romano-italici. Non meglio (anzi) andava nella Sicilia saracena, dove i mussulmani e i convertiti erano liberi mentre i cristiani greco-italici sopravvissuti alla sanguinosa invasione dell’isola erano costretti a pagare una tassa per poter esercitare la loro religione (c’è chi dice che questa sia l’origine del “pizzo”…).
I Saraceni sarebbero poi stati spazzati via da nuovi invasori, i Normanni, completando così il quadro geografico dell’Italia moderna e realizzando quell’unione delle varie realtà geografiche dalla Sicilia alle Alpi, dalla Dalmazia (oggi non più italiana) alla Corsica. Anche l’arrivo dei Normanni non fu affatto una passeggiata di salute, anche se il loro numero esiguo rispetto a quello di Goti e Longobardi li fece fondere nel crogiuolo nazionale molto più velocemente dei loro predecessori germanici. Ma furono gli ultimi.
Per quattro secoli l’Italia fu dunque una regione dove popoli immigrati si comportavano da padroni sugli autoctoni. Per arrivare alla fusione definitiva e alla nascita degli “italiani” come noi li conosciamo oggi sono stati necessari oltre quattrocento anni, e non esattamente dei più facili e comodi in cui vivere.
Una storia che vale per tante altre realtà. La Francia di Raspail non è diversa, con la fusione fra Galli e Romani costata un mezzo genocidio da parte di Cesare, le invasioni germaniche e poi normanne – altrettanto sanguinarie e feroci – le guerre interne che portarono allo sterminio di intere popolazioni (come la crociata contro i Catari e le guerre per sottomettere la Bretagna).
Le isole britanniche a loro volta hanno una storia composta da invasioni successive, e sangue, sangue, sangue. La conquista romana è ferocissima (e la storia di Boadicea ne è uno dei tanti esempi), la partenza dei Romani tre secoli dopo, con l’arrivo di Angli, Sassoni e Juti, non diversa, tanto che le dure guerre fra vecchi e nuovi abitanti dell’isola è entrata nel mito col ciclo arturiano. Seguono le razzie e le invasioni vichinghe, poi quelle dei… Vichinghi di seconda generazione, i Normanni dalla Francia. Come sa chi ha letto “Ivanoe” di Scott, ancora oltre un secolo dopo la Battaglia di Hastings il Regno d’Inghilterra era diviso in una casta dominante normanna e i sottomessi anglosassoni trattati come pezze da piedi. Altro che “meticciato” da pubblicità delle mozzarelle con multicolori studenti fuorisede che suonano la chitarra su una terrazza romana davanti a una bella caprese…
Una storia che continuerà nei secoli successivi, con l’annessione del Galles ancora romano-celtico e poi di Scozia e Irlanda. Storie di sangue, genocidi e sostituzione etnica da parte di Londra, che quando non poté impiegare la fame e la carestia per annientare le popolazioni celtiche, le ha usate come coloni e carne da cannone sui campi di battaglia del nascente impero d’oltremare e nelle guerre sul continente: svuotare le province ribelli delle teste calde per sostituirli con sudditi etnicamente graditi e ossequiosi.
Eppure, nonostante tutto questo sangue, mentre l’Inghilterra è riuscita a unificarsi e oggi nessuno pensa a staccare il Kent jutico dall’Anglia sassone, nonostante tutto, i tentativi di riunire le Isole Britanniche sotto un’unica lingua e farne un’unica nazione (la Gran Bretagna) sono quasi completamente falliti, con l’Irlanda che se ne distacca nel 1921 e Scozia e Ulster sono oggi pressoché autonome e con fortissime pulsioni separatiste.
La differenza fra la sorte dell’Inghilterra e quella della Gran Bretagna è che la prima si forma durante la gestazione delle moderne nazioni, la seconda quando le nazioni sono già nate. La Scozia è digià una nazione quando viene unita dinasticamente all’Inghilterra.
Lo stesso discorso si può fare per la penisola iberica: durante la Reconquista Leon e Castiglia si fondono prima della nascita delle nazioni, mentre l’unione dinastica fra Castiglia e Catalogna, avvenuta in pieno XV secolo, non ha mai dato origine a una nazione indistintamente unita. Tanto che la Catalogna tutt’ora aspira alla secessione da Madrid. Il Portogallo, a sua volta, ha preso una sua strada nazionale senza mai unirsi con gli altri popoli iberici, e la breve parentesi di unione dinastica sotto Filippo II di Spagna non ha mai nemmeno sfiorato l’idea di fondere i lusitani con castigliani e catalani.
Una volta nate le nazioni, insomma, restano tali. Etruschi, Sabini e Latini potevano fondersi nei Romani. Longobardi e Romani potevano fondersi (con più difficoltà) nei moderni italiani. Ma catalani e castigliani restano tali, anche sotto la gloriosa corona di Spagna.
La prova del 9: gli immigrati in Italia (before it was mainstream)
L’era della gestazione delle nazioni è stata dunque sì un’era di “meticciato”. Ma essa costava sangue, segregazioni, schiavitù, massacri e saccheggi, oppressione del nuovo arrivato sull’autoctono. La storia insegna che non esistono cose come “popoli che convivono in pace”. I Romani schiacciano gli Iceni, i Sassoni schiacciano i Romani, i Normanni schiacciano i Sassoni… Quando alla fine di secoli di sangue la moderna Inghilterra nasce come “meticciato” fra i suddetti popoli, essa si avventa su quelli vicini – bretoni, gallesi, scozzesi, irlandesi. Alcuni vengono letteralmente eliminati (i bretoni, fuggiti oltremanica) altri non fanno in tempo a costituire la loro nazione, i gallesi, e finiscono come provincia sfruttata di Londra, tanto che la loro bandiera neppure compare nell’Union Jack. Irlanda e Scozia resistono e costituiscono delle nazioni autonome per qualche secolo, subendo comunque fra 1600 e 1800 la sostituzione etnica e il tentativo di genocidio da parte inglese.
In ogni caso, dopo la formazione delle nazioni non c’è più alcuna possibilità che queste si fondano fra loro. Gli scozzesi restano scozzesi e gli inglesi inglesi. Per tenerli insieme non ci sono che due strade: fare appello alla fedeltà dinastica o sterminare\costringere a emigrare i più irriducibili.
Dopo la conquista normanna della Sicilia, l’Italia è pressoché unificata a livello etnolinguistico. Un secolo dopo alla corte di Palermo nasce l’italiano letterario e due secoli dopo Dante studiando la lingua degli italiani ne riconosce una dozzina di varietà, diverse ma perfettamente intellegibili fra loro. Gli italiani si riconoscono e vengono percepiti dagli stranieri come un popolo, a dispetto della frantumazione politica della penisola.
Gli ultimi immigrati da fuori che si fondono completamente nel tessuto nazionale sono i Normanni. Dopo di loro entreranno altri popoli in Italia, per lo più genti in fuga davanti alle armate ottomane. Ma essi manterranno la loro identità nazionale. Grecanici, albanesi, slavi, zingari e catalani giungono nel nostro Paese fra il XIV e il XVI secolo mantenendo la loro identità originaria. Sono parti di nazioni fatte che entrano in contatto con un’altra nazione fatta. Vengono sì accolti (del resto la densità di popolazione lo consentiva) ma come acqua e olio questi popoli non si fondono con gli autoctoni, per quanto vivano pacificamente in tutta la penisola gomito a gomito con gli italiani, e lo fanno tutt’oggi nelle cosiddette “isole linguistiche”.
Meno bene invece va in Istria e Dalmazia, dove gli immigrati slavi dai Balcani, accolti quando non chiamati da Venezia per ripopolare le terre devastate da guerre e pestilenze e combattere come mercenari (“i fa i mestieri che i veneti no i vol pì far!“), nel XIX iniziano a maturare una coscienza nazionale moderna – peraltro su imitazione del Risorgimento italiano – e ad entrare in concorrenza con gli italiani locali. Com’è finita questa storia di “accoglienza”, “convivenza” e “meticciato” (virgolette sarcastiche d’obbligo) lo sappiamo bene: polarizzazione nazionalista, scontri, snazionalizzazione reciproca (prima contro gli italiani, poi contro gli slavi, di nuovo contro gli italiani), esodo della comunità italiana dalla Dalmazia (nel XIX secolo) e dall’Istria (nel 1943-’54), foibe. Una storia che dovrebbe essere molto istruttiva, di questi tempi.
La sfida del XXI secolo
Dunque, la storia ci insegna o non qualcosa? Con il Basso Medioevo praticamente le identità nazionali in Europa sono formate, mature, cristallizzate. I casi di spostamenti interni di popolazioni si fanno sempre più rari e con la notevole (e meritevole d’approfondimento, ma non in questa sede) eccezione degli ugonotti francesi espulsi per motivi confessionali durante il periodo delle Guerre di Religione, praticamente nessun altro popolo che si sposta nell’Europa moderna e contemporanea finisce per amalgamarsi con gli autoctoni: le colonizzazioni interne al nostro continente finiscono normalmente malissimo, come la storia dell’Istria o dei tedeschi nell’Europa orientale dimostrano ad abundantiam. Le masse di lavoratori che emigrano nel XX secolo dai paesi poveri a quelli industriali è un’altra vicenda di sfruttamento, pogrom (come quello anti-italiano ad Aigue-mortes, in Francia) e dolore, con una fetta che rientra bon gre mal gre nella patria d’origine e l’altra che per guadagnarsi la parificazione agli autoctoni deve sudare lacrime e sangue.
Oggi l’Italia – che era un paese monoetnico fino alla fine del secolo scorso – vede la sua popolazione autoctona scendere con paurosa rapidità sotto la soglia del 90% del totale dei residenti. In prospettiva, gli immigrati, fra nuovi arrivi e nuove nascite sul territorio nazionale, puntano a diventare una fetta sempre più ampia della popolazione complessiva. Tutte le comunità presenti sul nostro territorio, nonostante ogni tentativo della propaganda immigrazionista di presentarle come “integrate” se non direttamente “nuove italiane” (magari per meri meriti sportivi), mantengono la loro specificità nazionale d’origine, tanto più quando provenienti da continenti lontani, da mondi totalmente differenti dal nostro per religione, tradizioni, costumi. La stessa adesione linguistica non trasforma gli stranieri in “nuovi italiani” nella maggioranza dei casi, e questo perché, come visto, l’epoca delle identità nazionali non è affatto terminata. Di sicuro non basta “tifare per la stessa squadra dei nostri figli” per fare di un immigrato un “nuovo italiano”, come certi esponenti politici hanno sostenuto.
Non per caso, dunque, i sostenitori dell’immigrazionismo e del “meticciato” sono anche i più fanatici assertori d’ogni possibile maledizione dello spirito nazionale italiano: essi hanno compreso più o meno bene come la natura di popolo-nazione degli italiani sia un ostacolo all’immigrazione e alla società multirazziale che essi sconsideratamente sognano, dunque non c’è mistificazione storica, argomento di propaganda o falsificazione che essi non siano disposti a utilizzare pur di convincere gli italiani che non sono un popolo, che la loro natura è intrinsecamente “meticcia” e che accogliere la gente sui barconi oggi è cosa buona e giusta perché del resto abbiamo accolto i Troiani tremiladuecento anni fa e i Longobardi nel VII secolo…
Quello che gli immigrazionisti non dicono, e non lo ammetteranno neppure sotto tortura, è che se esiste un parallelismo fra l’immigrazione dei secoli passati e quella di oggi, esso è il carico di sangue, morte e sofferenza che essa portava e che essa continuerà a portare. Un carico che non diminuirà affatto perché qualche bello spirito nel XVIII secolo ha sognato che esistono cose come “i diritti umani”. Le nazioni, realtà con ormai un migliaio d’anni di storia alle spalle, non possono essere cancellate nello spazio di un trentennio di propaganda e ingegneria sociale, ma anche quando vi si riuscisse, il processo di fusione fra i popoli autoctoni snazionalizzati e quelli immigrati sarà comunque foriero di infinite sofferenze, come ogni singolo caso storico del passato ci insegna.
Se dunque un personaggio politico ama davvero l’Italia e la sua storia non può seriamente chiedere che essa abbandoni il proprio retaggio nazionale, così faticosamente costruito in secoli e secoli. L’esperienza individuale, per quanto felice, di “integrazione” e “meticciato” non sono la normalità e non lo saranno mai. Se uno ama davvero questo paese deve essere capace di fare un passo di lato.