La tragedia del grande transatlantico italiano, affondato nell’Oceano Atlantico dopo una collisione con una nave svedese, nasconde molti retroscena, nobili e no. Figure coraggiose come il comandante Calamai e i suoi uomini si contrappongono ai molti personaggi che hanno cercato di cancellare le vere responsabilità del disastro. In un sorprendente mix di pregiudizi razziali, interessi economici e opportunismi politici. Smascherati da un libro-inchiesta
di Luciano Garibaldi su Storia in Rete Speciale “Sovranità Limitata”
Nel novembre 2024 ci ha lasciati Luciano Garibaldi, una delle colonne di «Storia In Rete» fin dal suo esordio in edicola, nel lontano 2005. Per anni e anni non c’è stato un solo numero che Luciano abbia saltato: puntuale e preciso mandava per tempo la sua rubrica delle lettere che, tradizionalmente, chiudeva il giornale con le sue risposte garbate, documentate, scritte in un italiano esemplare. Ora che la rivista riprende il suo cammino (cosa che gli farà sicuramente piacere), vogliamo, almeno per questo primo numero, mantenere la tradizione e pubblicare la lettera principale della rubrica che Luciano aveva preparato per il numero di «Storia In Rete» che non è uscito per la chiusura temporanea dell’estate 2023. È un piccolo omaggio ad un grande professionista, un punto di riferimento che per chi coniuga giornalismo e Storia. Ma è soprattutto un modo per ricordare e lenire la mancanza di un amico, generoso e affettuoso come pochi. (SIR)
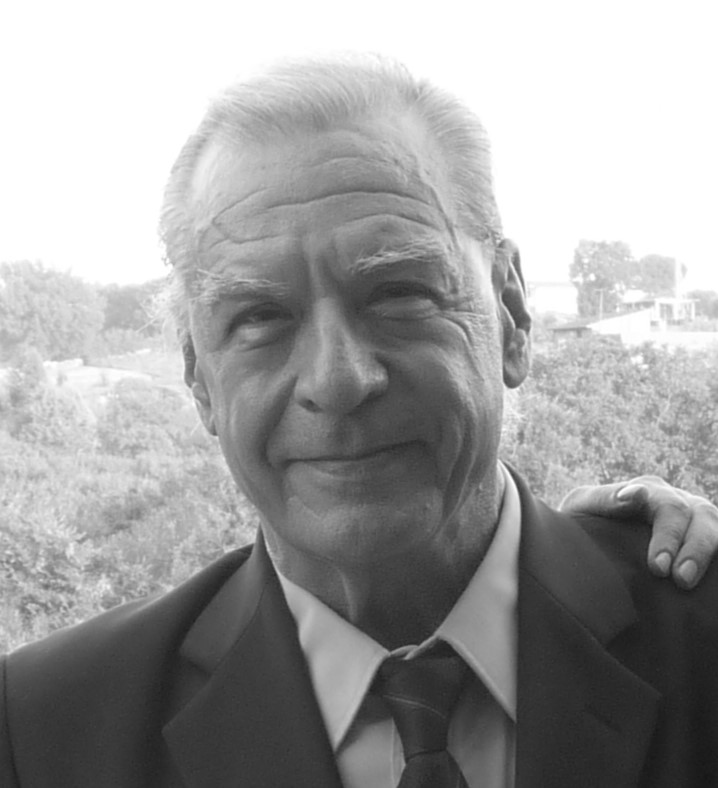
I misteri dell’Andrea Doria
È vero che la tragedia dell’Andrea Doria, il transatlantico italiano affondato nell’Oceano Atlantico oltre mezzo secolo fa, è stata la più grave della storia dopo quella del Titanic? Ed è vero che le responsabilità della nave che la speronò e la mandò a fondo, la svedese Stockholm, sono state occultate fino ad oggi? Di chi fu la colpa di quel naufragio ormai entrato nella storia?
GAETANO BARISONE
La Spezia
Proprio così, caro Barisone. C’è voluto più di mezzo secolo perché finalmente venissero rese note, nel particolari, le conclusioni cui pervenne la commissione d’inchiesta della Marina Mercantile italiana sulla tragedia del transatlantico Andrea Doria, speronato dalla svedese Stockholm alle 23,11 ora locale di mercoledì 25 luglio 1956 al largo di New York, in prossimità del faro di Nantucket. Lo ha provato Maurizio Eliseo, noto progettista di navi e appassionato di storia, nel suo libro «Andrea Doria: 101 viaggi», edito da Hoepli. Maurizio Eliseo ha ricostruito nei particolari l’istruttoria conclusasi il 29 agosto 1957, ma i cui risultati non furono mai divulgati per non confliggere con quelli della commissione svedese che invece attribuiva la colpa agli italiani. E vedremo perché. L’Andrea Doria, il transatlantico più elegante, più famoso e più veloce d’Italia, assieme al gemello Cristoforo Colombo (ricordiamo che all’epoca l’aviazione civile era agli albori e la gente si spostava tra l’Europa e gli Stati Uniti quasi esclusivamente in nave), era partito da Genova il 17 luglio di quel 1956, al comando del capitano Piero Calamai, con 1134 passeggeri e 572 membri dell’equipaggio. L’arrivo a New York era previsto per la tarda mattinata di mercoledì 25 luglio. La nave, lunga 212 metri, era un autentico gioiello della tecnica, nonostante gli svedesi tenteranno, dopo la tragedia, di dimostrare che era stata progettata in violazione delle più elementari norme di sicurezza, commissionando all’uopo addirittura un libro allo scrittore Algott Mattsson.
Alle 22,40 del 25 luglio, procedendo in una fitta nebbia, l’Andrea Doria superò il faro di Nantucket alla velocità di 21,8 nodi. Cinque minuti dopo, alle 22,45, il radar segnalò una nave in avvicinamento a meno di 10 miglia, sulla destra rispetto alla rotta del transatlantico italiano. Fenomeno stranissimo perché quella era la rotta delle navi dirette a ovest, cioè verso la costa USA, mentre le unità provenienti dall’America dovevano viaggiare molto più a nord. Immediatamente, il comandante Calamai ordinò di accostare di 4 gradi a Sud, spostarsi cioè a sinistra per aumentare la distanza. Ma sullo Stockholm (transatlantico più piccolo del Doria, lungo 159 metri e con a bordo 534 passeggeri), in quel momento si trovava al comando il terzo ufficiale Cartens Johannsen (il comandante, capitano Gunnar Nordenson, stava riposando) il quale commise un madornale errore, anzi più d’uno. Non solo non diede neppure un’occhiata al radar, cosa che gli avrebbe segnalato l’arrivo di una nave ma, per evitare la collisione con il faro di Nantucket (ricordiamo che sulla zona gravava una fitta nebbia), spostò la rotta a destra, anziché a sinistra, in maniera assolutamente eccessiva, senza neppure preoccuparsi di azionare le sirene.

Quando la gigantesca sagoma dell’Andrea Doria si profilò nella nebbia con il suo mare di luci, era ormai troppo tardi per evitare la collisione. Alle 23,11, la prua dello Stockholm penetrò nella fiancata destra dell’Andrea Doria, uccidendo nel sonno 47 passeggeri tra i quali il corrispondente dall’Italia del «New York Times» Camillo Cianfarra e la figlioletta Joan, di 11 anni. Cianfarra tornava a New York con la moglie e le due figlie per le vacanze estive. Sulla Stockolm vi furono cinque morti. Decine i feriti su entrambe le navi. Subito furono lanciati gli SOS e il primo soccorso arrivò alle 2 del mattino. Era il transatlantico francese Île de France, partito da New York, il cui equipaggio, calate in mare le scialuppe, iniziò a portare al sicuro i passeggeri delle due navi. Poco dopo seguì il guardacoste americano Evergreen, e Calamai, infaticabile organizzatore delle operazioni di soccorso, sperò che la sua nave potesse essere rimorchiata a New York. Ma l’Andrea Doria continuava ad inabissarsi lentamente sulla fiancata destra dal cui squarcio tonnellate di acqua seguitavano ad entrare nella nave. Così, l’ordine di Calamai fu di trasbordare tutti i passeggeri, e poi anche il personale d’equipaggio, sulle navi che continuavano ad arrivare sul posto, mentre le radio di tutto il mondo continuavano a trasmettere le ultime notizie sulla tragedia. All’alba, sul transatlantico italiano restavano il comandante Calamai e dodici ufficiali. «Voi andate, resto io», disse Calamai. «Se lei resta, restiamo anche noi», fu la risposta. (Sono testimone diretto di questo episodio perché allora, giovane cronista del quotidiano della sera «Corriere Mercantile» di Genova, seguivo minuto per minuto l’evolversi degli eventi dagli uffici della società di navigazione «Italia», armatrice dell’Andrea Doria, in piazza De Ferrari, a Genova). Alle 5,30 Calamai decise di lasciare la nave che, alle 10,09, sprofondò negli abissi del mare.
Il processo per accertare le responsabilità della sciagura si aprì a New York e si concluse dopo quattro mesi con un nulla di fatto. «Pura fatalità», scrissero i giudici nella sentenza. Ma, riportate nel libro di Maurizio Eliseo, le considerazioni dell’avvocato di parte civile Leonard Matteson sono brucianti: fu un verdetto falsato da pregiudizi razziali (secondo i giudici americani, i marinai svedesi erano di sicuro meno approssimativi e inaffidabili di quelli italiani) e inquinato dal dispetto che esisteva in America per la concorrenza che l’Andrea Doria e la Cristoforo Colombo stavano facendo ai transatlantici americani Independence e Constitution, fino a poco tempo prima esclusivisti della linea New York – Genova. A ciò si aggiunse un accordo sotterraneo tra le due Compagnie, la società di navigazione «Italia» (dipendente dall’IRI) e la «Svenska Amerika Linye», per risarcire in parti uguali, con la non certo generosa somma di sei milioni di dollari, le famiglie delle vittime. Accordo favorito dall’interesse dei cantieri navali Ansaldo (anch’essi facenti parte dell’IRI) a non inimicarsi la Compagnia svedese, che aveva appena commissionato ai cantieri genovesi la costruzione della nave ammiraglia della flotta, la Gripsholm. Erano a rischio 20 mila posti di lavoro: lavoratori genovesi, per la stragrande maggioranza iscritti alla Cgil e al Pci. «Non è il caso», pensò De Gasperi. E ad essere sacrificato fu l’eroico comandante Piero Calamai il quale, ad onta dei risultati della commissione d’inchiesta (che aveva proposto un encomio solenne per lui e per altri 48 membri dell’equipaggio, tutti indicati nominativamente), non fu mai più richiamato in servizio e morì in solitudine nel 1972.

Ai margini di questa a suo modo storica vicenda, non è possibile dimenticare, senza rendere omaggio alle loro virtù sportive e civili, ben venti sub che, in oltre mezzo secolo, hanno perduto la vita nei tentativi di esplorare il relitto dell’Andrea Doria, adagiato a 70 metri di profondità e a 180 miglia da New York, in acque infestate da squali e percorse da continue correnti. Tra questi valorosi sportivi, David Bright, che si era immerso ben 120 volte e che in seguito perderà la vita nell’ennesimo tentativo di documentare la tragedia del Doria. Bright, fra l’altro, era il presidente dell’Associazione dei superstiti americani dell’Andrea Doria, alla testa della quale era succeduto a Anthony Grillo. Come vede, caro Barisone, i misteri d’Italia sono proprio tanti, e non necessariamente tutti politici.


