La rimozione dalla memoria collettiva di un personaggio o di un evento storico-culturale è un fenomeno quanto mai diffuso e non solo di questi tempi, durante i quali è stato sostituito da quello più drastico della cancellazione: la ormai tristemente famosa cancel culture, che dagli Stati Uniti si è diffusa come una epidemia anche nel Vecchio Continente.
Un personaggio importante che ha vissuto sulla sua pelle questo fenomeno nel secolo scorso è lo scrittore americano Ezra Pound (1885-1972), uno dei massimi poeti del 900, famoso (nonostante la damnatio memoriae di cui è stato vittima) per la sua opera principale, i Cantos, un poema incompiuto in 117 canti a cui ha lavorato dal 1917 fino agli ultimi anni.
Il suo caso è esemplare e la sua colpa per le autorità del suo Paese è imperdonabile: predicare la pace da una radio italiana dalla fine del 1940 al 25 luglio del 1943, tessendo anche le lodi del regime fascista. Una colpa imperdonabile che travolge agli occhi dell’opinione pubblica anche la sua opera poetica. La critica è semplice: se è un fascista non può essere un grande; ma se è un fascista ed è un grande non può che essere un pazzo. Tra queste Scilla e Cariddi si muoveranno i giudizi su Pound negli USA dai suoi primi interventi in radio fino alla sua morte, nel 1972, e anche oltre.
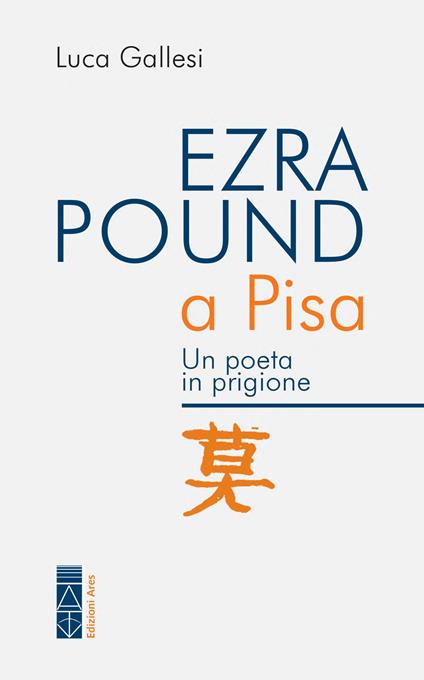
Su questo intreccio perverso interviene il recente saggio di Luca Gallesi (Ezra Pound a Pisa. Un poeta in prigione, Edizioni Ares, pp.152, € 12,00), un autore che ha al suo attivo, tra l’altro, nella collana Poundiana delle stesse edizioni, da lui diretta, due altri saggi dedicati al poeta americano.
L’Autore ricostruisce brevemente il trasferimento di Pound in Europa dal 1908 fino alla decisione di stabilirsi nel 1925 a Rapallo, dove lavora al suo poema, continua a tradurre Confucio e sviluppa le sue teorie economiche contro l’usura (di qui anche il suo presunto antisemitismo), gli speculatori finanziari e i mercanti di cannoni, ai quali attribuirà la responsabilità di tutte le guerre e quindi anche della seconda guerra mondiale.
Come conseguenza di queste posizioni, del suo amore per l’Italia e dell’ammirazione per Mussolini, il poeta ‘scende in campo’ alla fine del 1940, inaugurando una serie di interventi a Radio Roma, nelle trasmissioni destinate all’estero, durante le quali attacca Roosevelt, bollato come un traditore che vuole trascinare gli Usa in un conflitto contrario alla Costituzione americana, e si rivolge ai suoi compatrioti per dissuaderli dalla guerra.
La reazione è durissima. Lo stesso Presidente americano il 1° ottobre del 1942 sollecita il Procuratore generale, F.B.Biddle, a intervenire e, a seguito di ripetute indagini, il 26 luglio del 1943 viene spiccato un mandato d’arresto contro Pound, mentre resta senza risposta la sua replica allo stesso Procuratore nella quale invoca la libertà di parola, respinge l’accusa di tradimento e ribadisce che i suoi interventi sono sempre stati a favore della pace.
La fine della guerra segna anche la fine della libertà per il poeta, che viene ‘catturato’ il 3 maggio da due partigiani e consegnato agli Americani che lo trasferiscono a Genova in serata. Gli interrogatori da parte di un ufficiale e di un agente dell’FBI vanno avanti dal 5 al 7 maggio in un clima apparentemente amichevole e si concludono con una dichiarazione firmata dello stesso Pound nella quale egli respinge nuovamente l’accusa di tradimento.
Questa situazione di calma apparente si interrompe improvvisamente il 24 maggio quando “l’inconsapevole prigioniero”, come lo definisce Gallesi, viene messo su una jeep e trasferito, unico civile, nel campo di prigionia militare costruito dagli Americani cinque chilometri a nord di Pisa. Al poeta viene riservato un trattamento ‘speciale’: una gabbia di ferro, rinforzata da filo spinato, all’aperto, nella quale il prigioniero seminudo deve stare sotto il sole o al freddo della notte con un secchio per i suoi bisogni.
Pound resiste fino al 18 giugno, quando, a seguito di un collasso per il caldo e lo stress, le autorità sono costrette a trasferirlo nell’infermeria. Qui ha la possibilità, con mezzi di fortuna, di rimettersi a scrivere. Sono The Pisan Cantos (I canti pisani), la parte forse più celebre del suo poema, che prendono i numeri dal 74 all’84 all’interno dell’opera. Invece di ascendere al Paradiso, secondo il progetto che precedeva gli ultimi eventi, il poeta dà voce alla sua discesa all’Inferno e alla rovina del suo mondo (l’Europa in primo luogo), cercando però, attraverso la memoria, di trovare tra le macerie quanto può contribuire alla sopravvivenza della tradizione.
Su questi Cantos, che verranno pubblicati nel luglio del 1948, si concentra l’analisi di Gallesi, che li definisce l’ancora di salvezza del poeta nella disperazione del campo di prigionia, ma anche il suo testamento spirituale. Il capitolo 4 del saggio è diviso in 11 paragrafi, tanti quanti sono The Pisan Cantos, e costituisce unaguida preziosa per orientarsi nella poesia di Pound, nella quale si alternano, spesso senza una logica e un ordine apparenti, miti, ideogrammi, citazioni e quant’altro viene suggerito al poeta dalla fantasia e dall’ispirazione di quei giorni drammatici.
Questa atmosfera di tranquilla, anche se dolorosa solitudine, viene improvvisamente interrotta dall’ordine di trasferire Pound negli Stati Uniti. Viene prelevato il 17 novembre e atterra all’aeroporto di Bolling Field, D.C., la sera del giorno successivo. Il poeta vorrebbe affrontare il processo per l’imputazione di tradimento difendendosi da solo, tanto gli appare evidente la sua innocenza. Ma le insistenze della moglie Dorothy e di alcuni amici lo convincono ad accettare come avvocato Julien Cornell, il quale sceglie subito una strategia difensiva che mette in discussione la sua sanità mentale, in particolare dopo le dure esperienze detentive. Il legale è convinto che si tratti dell’unica strategia possibile per evitare un processo per tradimento che potrebbe concludersi con la condanna a morte.
Pound, che vorrebbe il processo per difendere le sue ragioni, segue così, più o meno consapevolmente, una strada che glielo precluderà per sempre, a dispetto dei princìpi fondamentali dell’habeas corpus. Come scrive Gallesi: “una volta imboccata la strada dell’insanità mentale, non sarebbe stato più possibile tornare indietro: non sarebbe stato infatti credibile l’ipotesi che Pound fosse sufficientemente pazzo da non essere processato, ma fosse abbastanza sano di mente da poter essere liberato e tornare in Italia”.
Così, dopo la perizia di quattro psichiatri letta nell’udienza del febbraio 1946, a Pound si aprono le porte del St. Elizabeths Hospital, il manicomio criminale dove resterà rinchiuso per ben 12 anni, fino a quando verrà dimesso per essere affidato alla tutela della moglie che lo riporterà in Italia.
Nel frattempo, come si è detto, The Pisan Cantos vengono pubblicati nel luglio del 1948, scatenando un dibattito acceso tra critici e letterati. L’opera doveva essere giudicata separatamente dal suo autore? Doveva essere letta come manifesto politico o come poesia? Poteva essere giudicata l’opera di un pazzo?
Su questi interrogativi si abbatte come un fulmine il conferimento ai Cantos, nel febbraio del 1949, del prestigioso premio Bollingen (dal nome della fondazione omonima), attribuito da una giuria selezionata dalla Biblioteca del Parlamento. Risultato: scandalo e clamore, con gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica ‘colta’ oscillanti tra valutazioni poetiche, politiche e psichiatriche.
Dopo poche settimane, Radio Mosca, come ricorda Gallesi, esprimeva questo lapidario giudizio: “Uno è costretto a chiedersi quanto bassa e miserabile debba essere la qualità della poesia borghese moderna in America se anche i vaneggiamenti di un pazzo reo confesso possono vincere un premio letterario”.
Poco alla volta, scrive l’Autore, “si diffonde l’idea che il libro debba essere in qualche modo separato dal suo autore e soprattutto dalle sue idee”. “Fra cinquant’anni, ebbe a dichiarare il poeta americano Richard Eberhart, la politica sarà dimenticata e resterà la poesia”. “Cinquant’anni dopo, invece, osserva amaramente Gallesi nella conclusione, possiamo dire che forse è avvenuto l’esatto contrario”.


