di Alberto Scuderi per Storia in Rete del 1° aprile 2025
A definire gli anni Ottanta negli ultimi tempi ci hanno provato in parecchi, anche se spesso a senso unico. Dandone al solito una versione tutta edonismo e opulenza che alla lunga si è rivelata tanto parziale quanto ingiusta. Da questo saggio di Diego Gabutti, Ottanta. Dieci anni che sconvolsero il mondo (Neri Pozza, 2025) pare di capire, invece, che la difficoltà maggiore nell’analizzare quel decennio, contraddittorio come ogni fase di transizione, risieda nella sua scandalosa e cupa attualità. Nel senso che proprio in quegli anni, dove a cambiare radicalmente furono politica, economia, cultura e costumi di una società intera, si sarebbero gettate le basi del nostro presente. Nel bene ma, soprattutto, nel male. Effettivamente, dopo anni di massiccia e costante crescita, dal secondo dopoguerra alla crisi energetica del ‘73 – i “trenta gloriosi” -, il mondo di lì a poco non sarebbe stato più lo stesso: «fino a un momento prima c’era piena occupazione, l’industria prosperava, l’ascensore sociale funzionava, si andava presto in pensione, sanità gratuita per tutti». Poi giungono, d’improvviso, gli Ottanta, «l’età del brusco risveglio». In tal senso, l’autore, già editorialista del Giornale di Montanelli e oggi battitore libero – si vedano i recenti Evasioni (Milieu, 2024) e Nel West con Sergio Leone (Perrone, 2024) -, compie una ricostruzione puntuale dei principali fatti del decennio – o del suo lato oscuro, se si preferisce -, con prosa raffinata e una buona dose d’ironia.
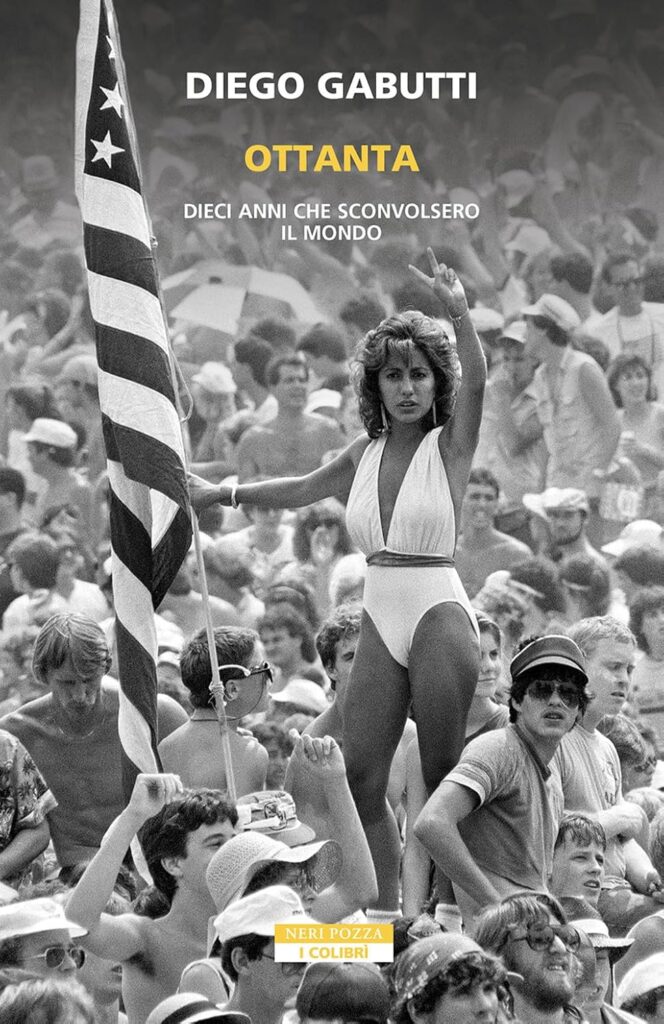
Innanzitutto, muovendo dalle vicende internazionali. Dall’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Urss, voluta da Leonid Il’ic Breznev, ignaro che quello sarebbe stato il campo di battaglia fatale della potenza russa e di tutto il comunismo; all’ascesa della stella di Ronald Reagan, il quale divenuto presidente degli Stati Uniti compirà il miracolo di riabilitare il paese agli occhi del mondo dopo la sconfitta in Vietnam; passando per la rivoluzione khomeinista in Iran, capace di spegnere i sogni di un Medioriente amico dell’Occidente e, al contempo, fare dell’Islam radicale e oscurantista un modello, un’occasione di riscatto. In economia, sono gli anni della cosiddetta “Reaganomics”, del liberismo dell’Università di Chicago, con il professore e ideologo Milton Friedman intento a smontare pezzo per pezzo le teorie del massimo sostenitore dell’interventismo statale: John Maynard Keynes. Così come, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, la rivoluzione hi-tech di Internet, pc e cellulari avrà nel medesimo lasso di tempo la propria scintilla visionaria, ancor prima delle sue prime concrete (e inquietanti) manifestazioni.
E in Italia cosa succede? Il 14 ottobre 1980 c’è la marcia dei 40mila di Torino, dove capi e capetti Fiat, guidati dal quadro d’azienda cinquantaquattrenne Luigi Arisio, mettono all’angolo sindacato e movimento operaio. Nasce l’impero mediatico di Mediaset ad opera di un imprenditore piuttosto rampante di nome Silvio Berlusconi.
Scoppiano gli scandali legati alla P2 e alla mafia di Cosa Nostra. Inizia la stagione socialista dei governi guidati da Bettino Craxi che con l’affaire di Sigonella si condannerà ben presto ad un suicidio politico. Contestualmente, aumenta il debito pubblico e si manifestano le prime avvisaglie di un sistema destinato a implodere con Tangentopoli e l’inchiesta di Mani Pulite.
Un capitolo a parte è dedicato al celebre Dakota Building, tra i palazzi più antichi e maledetti di New York, progettato nell’Ottocento in stile gotico, e destinato a tornare più volte nel racconto. Per comprendere l’essenza, la vera natura degli Eighties, sembra dire Gabutti, occorre passare da qui, dall’Upper West Side, esattamente di fronte a Central Park. Ai piani alti di questo edificio – già utilizzato due anni prima come set per il film «diabolista» di Roman Polansky, Rosemary’s Baby – il 14 gennaio 1970 Felicia Maria Cohn Montealegre, sposata col compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, tiene un ricevimento a favore del Black Panther Party, l’organizzazione politica afroamericana che in quel periodo ha dei militanti in galera proprio a NY. Tra gli invitati, c’è anche il giornalista Tom Wolfe, «uno che sarebbe stato molto meglio non invitare». In quanto, alcuni mesi dopo, sul New York Magazine, di quello stesso ricevimento farà strame nel lungo articolo, diventato pamphlet di successo, dal titolo Radical chic, un resoconto dissacrante in cui Wolfe «evoca la figura del rivoluzionario da salotto, campione d’engagement, che veste abiti (e pensa pensieri) firmati». Sancendo, idealmente, la fine del sessantottismo e della controcultura d’ispirazione marxista. L’epilogo vero e proprio, l’evento spartiacque di quella generazione, arriverà in maniera traumatica qualche anno dopo, l’8 dicembre del 1980, giù dalle scale del Dakota, all’ingresso, quando John Lennon sarà ucciso con quattro pallottole sparate da Mark David Chapman.
Dunque, tra fanatismi religiosi e populismi, tecnologie fuori controllo e scontri di civiltà, gli anni Ottanta, lo si è capito, hanno aperto la strada a ciò che ingombra l’attuale presente. Ma anche prefigurato il nostro futuro prossimo. Nel 1984, infatti, esce nei cinema Terminator di James Cameron, dove si profetizza un’intelligenza artificiale maligna ai danni dell’umanità. E anche se nel sequel, di qualche anno dopo, il robot sceglie di stare dalla parte dell’uomo, oggi le paure e le ansie sono le medesime di allora, e non smettono di angosciarci.


